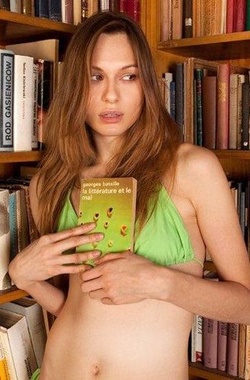-
Par riministoria le 21 Juin 2014 à 18:25
Cultura a Rimini tra 1600 e 1700.
Una mappa europea delle idee.
Introduzione.Il Sito riminese di Raffaele Adimari (Brescia, 1616) esce come rielaborazione di pagine «sparse» composte dal dottor don Adimario Adimari, rettore di Sant'Agnese e figlio del cavalier Nicolò.
Mons. Giacomo Villani (1605-1690) attribuì erroneamente il Sito all'olivetano di Scolca (al Covignano) padre Ippolito Salò, matematico, nipote di mons. Paolo che fu al servizio del cardinal Carlo Borromeo.
Raffaele Adimari ricevette in dono le 62 carte «sparse» (Elogio del sito riminese, ms. 617, BGR) di don Adimario il 20 dicembre 1605 dal nobile Francesco Rigazzi che le possedeva (Schede Gambetti 111 e 113 fasc. 1; 25, fasc. 76, BGR).
Rigazzi è il fondatore del collegio dei Gesuiti di Rimini. Nel 1610 dopo aver diseredato il figlio Giovanni Antonio («un bastardo criminale», lo definisce), lascia usufruttuaria la moglie Portia Guiducci. Alla di lei morte, i beni finiranno ai Gesuiti «col patto però, che detti padri siano tenuti a fondare in Rimino un Colegio nel quale siano obligati à gloria di Jddio et à benefitio della mia carissima patria insegnare, et fare tutte quelle operationi, che fanno ne gli altri Colegj d'Italia sì di legere publicamente come di ogni cosa solita da farsi da loro nell'altre».
Nel 1619, 1622 e 1626 («donatio inter vivos»), Rigazzi conferma le sue volontà. Dal 1627 i Gesuiti cominciano ad operare a Rimini. Nei giorni di Carnevale introducono una novità che provoca proteste: predicano in piazza. Il 14 giugno 1631 aprono la loro prima chiesa nel granaio di Rigazzi, con il nome di San Francesco Saverio. Il 22 agosto, Rigazzi muore. La vedova apre ai Gesuiti un pezzo della sua casa, dove da novembre s'inizia «la scola».
Torniamo agli Adimari. Le ricerche sulla loro genealogia hanno tormentato le più belle intelligenze locali. I risultati pervenutici confermano che la Storia può a volte essere più fantastica che veritiera, non per secondi fini ma semplicemente per eccesso di presunzione degli scrittori.
Il 23 agosto 1750 Giuseppe Garampi (a Roma dalla fine del 1746) attiva l'abate riminese Stefano Galli che gli scrive il 27 di aver consultato il manoscritto delle Famiglie riminesi di Raffaele Brancaleoni, non trovandovi «cosa veruna» di Raffaele Adimari o notizie per stabilire il suo grado di parentela con Adimaro. Galli nel Diario de' Morti (1610-1634) del canonico Giacomo Antonio Pedroni vede citato un Raffaele figlio di Pietro che però non ha sangue nobile essendo di «famiglia cittadinesca» [1].
Né Garampi né Galli avevano evidentemente letto il Sito di Adimari, dove l'autore (II, p. 54) dichiara che la congiura del 1498 contro Pandolfo Malatesti fu organizzata in casa dei suoi «antecessori», il cavalier Nicolò e «Adimario suo Padre».
Quando esce nel 1616 il Sito, era già compiuto da due anni il palazzo di Alessandro Gambalunga la cui prima pietra è del 1610. Gambalunga muore il 12 agosto 1619 lasciando al nostro Comune sia il palazzo (costato settantamila scudi) sia la biblioteca posta «nella stanza da basso». In Emilia si aprono molto dopo le biblioteche di Modena (1750), Ferrara (1753), Bologna (Universitaria, 1756), Parma (1769) e Piacenza (1778).
Alessandro Gambalunga è nipote di un maestro muratore lombardo approdato poi alla mercatura, e figlio di un commerciante «da ferro» arricchitosi con gli affari e le doti di quattro matrimoni. Nel 1583 circa a trent'anni si è laureato in Diritto civile e canonico a Bologna per fregiarsi del titolo, più pregiato di quello nobiliare che aveva acquisito e che oggi è giudicato «dubbio».
Sul «tronfio quanto spiantato ceto patrizio locale» ricordiamo quanto il bolognese Angelo Ranuzzi, referendario apostolico e governatore di Rimini, annota nel 1660: «Vi sono molte famiglie antiche e nobili che fanno risplendere la Città, trattandosi i Gentiluomini con decoro et honorevolezza, con vestire lindamente, far vistose livree et usar nobili carrozze: nel che tale è la premura et il concetto fra di loro, che si privano talvolta de' propri stabili, né si dolgono di avere le borse essauste di denari per soddisfare a così fatte apparenze».
Nel 1617 esce il primo tomo del Raccolto istorico di Cesare Clementini (1561-1624) che sarà completato dal secondo apparso postumo nel 1627. Severo il giudizio di Carlo Tonini: l'opera «eccetto che nella parte che comprende i tempi a lui più vicini, è in molta parte un tessuto di equivoci o granchi», e «basta che una notizia sia data da lui solo perché venga accolta con riserva e con sospetto» (Coltura, II, p. 144).
Nel 1582 Clementini entrò in Consiglio comunale, ricoprendo numerose cariche (fu capo-console) e svolgendo importanti incarichi diplomatici.
Sia Clementini sia Adimari raccontano la favola della fondazione di Rimini da parte di Ercole citando un frammento («Ariminum a comitibus Herculis conditum») attribuito a Marco Porzio Catone da un noto «impostore» umanista, Annio di Viterbo ovvero il domenicano Giovanni Nanni (1432-1502) che nel 1498 aveva pubblicato i diciassette volumi delle Antiquitatum, una raccolta di brani inventati di sana pianta ma presentati come opera di scrittori greci e romani selezionati da Beroso sacerdote Caldeo (III-II secolo a. C.): si va dalla creazione del mondo al diluvio.
Anche l'illustre Carlo Sigonio (1520?-1584) era stato tratto in inganno da Annio circa le origini di Bologna nell'opera del 1587 composta quale storiografo ufficiale (nominato nel 1568).
Raffaele Adimari è ricordato nelle cronache oltre che per il Sito anche per un'altra impresa curata diligentemente nell'agosto 1613: il trasporto da Recanati a Rimini della statua dedicata a Paolo V, divisa in tre blocchi.
Paolo V, eletto il 16 maggio 1605, era il successore di Clemente VIII che il 10 febbraio 1605 aveva punito Rimini, sottomettendone il vescovo (sino ad allora assoggettato al pontefice) all'arcivescovo di Ravenna, Pietro Aldrobandini suo nipote. Clemente VIII morì poco dopo, il 27 aprile.
Proposta nel 1610, approvata l'anno successivo (non sapendo però «dove pigliare i denari») ed inaugurata nel 1614, la statua fu segno di ringraziamento al papa per la nomina a cardinale (1608) del concittadino Michelangelo Tonti, arcivescovo di Nazaret, il quale era stato festeggiato con pubbliche manifestazioni di giubilo culminate in disordini, e descritte da Carlo Tonini come «colmo di gioia» e «straordinaria libertà non divietata da alcuno».
Alla fine, per merito della gioventù, radunata in casa d'Ercole Paci, cavaliere di Santo Stefano, se ne andarono in fumo botti, tavolati delle botteghe e persino le panche delle chiese e delle scuole con danni per tremila scudi (Storia, V, II, pp. 677-678).
Altri disordini si verificano nel 1615, con la distruzione del ghetto degli Ebrei situato in via Sant'Andrea, in un tratto che andava dall'oratorio di Sant'Onofrio alla cosiddetta «Costa del Corso»: «e in quella occasione si vide l'odio popolare contro quella gente», osserva Carlo Tonini che poi nel suo Compendio giudica l'episodio «di minor momento» e quindi da trascurare (C. Tonini, Storia, V, I, 410; Compendio, II, p. 322).
La rivolta popolare contro gli Israeliti nel 1615 è favorita dall'atteggiamento persecutorio di alcuni nobili, tra cui va ricordato un personaggio di spicco nella vita romana ed in quella politica italiana, Giovanni Galeazzo Belmonti.
Nell'ostilità contro gli Ebrei gioca un ruolo fondamentale pure la propaganda antisemita svolta dai padri Girolomini o Romiti di Scolca, che convincono il cardinal legato Domenico Rivarola ad ordinare l'abbattimento dei due portoni del ghetto posto lungo la contrada di Sant'Andrea (via Bonsi), nel tratto che va dall'angolo verso piazza Malatesta degli attuali Bastoni Occidentali detti allora «Costa del Corso», sino all'oratorio di Sant'Onofrio. Questo oratorio era di proprietà dei padri Girolomini sin dal 1494.
La cronaca di mons. Villani data al 15 giugno la demolizione delle porte del ghetto, dal quale la «perfida gens Iudeorum» aveva ricevuto già l'ordine di allontanarsi [Cfr. C. Tonini, VI, 2, p. 760].
Dell'antisemitismo secentesco restano profonde tracce nelle pagine composte da Carlo Tonini sue secoli e mezzo dopo: «Così la Città nostra ebbe il contento di vedersi liberata da quella odiata gente» [Cfr. C. Tonini, VI, 2, p. 761].
I fatti del 1615 sono raccontati con toni sbrigativi, utili soltanto a dichiarare la pubblica felicità per la 'partenza' di gente a cui erano attribuite soltanto scelleratezze, come testimonia una cronaca di Anonimo [questa cronaca, datata 1728, racconta le vicende riminesi a partire dall'anno 1601] in cui leggiamo che la cacciata degli Ebrei avvenne «per le infinite indegnità che commettevano contro la nostra Santa Fede, ed imagini de' Santi, ed altre enormità le quali non è da me dirle».
Nota. Il titolo di queste pagine, «Cultura a Rimini tra 1600 e 1700» restringe la cronologia iniziale di qualche anno perché, «in buona sostanza» (come diceva un personaggio di telefilm di successo), occorrerebbe partire dalla chiusura del Concilio tridentino, durato dal 1542 al 1563. Ma scrivere un titolo come «Cultura a Rimini dall'età post-tridentina a quella napoleonica» mi sembrava un poco sovrabbondante.
Bibliografia.
La «cronaca di Anonimo» che troviamo cit. in Carlo Tonini (cfr. VI, 2, p. 761), è il «Compendio di Storia riminese fino al 1726 posseduto già dal sacerdote D.n Luigi Matteini», come si legge in altro testo di C. Tonini, il tomo II della sua Coltura letteraria, Rimini 1884, p. 532.
F. G. Battaglini, Memorie istoriche di Rimino, ed. an., Rimini 1976
P. Delbianco, La biblioteca Gambalunghiana, in «Storia illustrata di Rimini», IV, Milano, 1991, pp. 1121-1136
G. Rimondini, I Gesuiti a Rimini, 1627-1773, Rimini 1992, passim
C. Casanova, La storiografia a Bologna e in Romagna, «Storia dell'Emilia Romagna», II, Imola 1977
Per la statua di Paolo V, cfr. il volume Paolo V in Rimini, Arengo Quaderno n. 3, 2004
Per le vicende ebraiche del XVIII sec., cfr. A. Montanari, Fame e rivolte nel 1797. Documenti inediti della Municipalità di Rimini, «Studi Romagnoli» XLIX (1998), Stilgraf, Cesena 2000, pp. 671-731; e Furore dei marinai, «Studi Romagnoli» LIII (2002), Stilgraf, Cesena 2005, pp. 448-511.
Per le vicende ebraiche, si veda anche «L'heretico non entri in fiera». Società, economia e questione ebraica a Rimini nei secoli XVII e XVIII. Documenti inediti.
Storia degli Ebrei a Rimini. Serie completa degli scritti.
Antonio Montanari
-
Par riministoria le 3 Août 2013 à 17:50
Duecento anni fa, i francesi occupano Rimini, allora territorio dello Stato della Chiesa. I soldati di Bonaparte entrano in città la sera del 4 febbraio 1797. Napoleone ha ripreso due giorni prima la guerra contro il Papa, rompendo l'armistizio del 23 giugno 1796, che aveva chiuso la prima fase della «campagna d'Italia», cominciata il 12 aprile dello stesso anno. Il 14 maggio era stata presa Milano, tra 18 e 19 giugno Bologna.
Il 31 gennaio '97 Bonaparte ha lanciato da Bologna un avviso ai romagnoli: «Qualunque Villaggio o città in cui all'avvicinarsi dell'Armata Francese si dia campana a martello, sarà sull'istante bruciata, ed i Magistrati ne saran fucilati». Nella dichiarazione di guerra del primo febbraio, Napoleone accusa la Corte di Roma di aver «intrapreso delle negoziazioni ostili contro la Francia con la Corte di Vienna». Il 12 gennaio alla Mesola, i francesi hanno intercettato un corriere diretto a Venezia con missiva del Segretario di Stato Cardinal Brusca, indirizzata al Prelato Albani inviato del Papa a Vienna. Nella lettera si parlava dei negoziati per concludere un'alleanza, e di «bande» austriache da far giungere in Romagna.
Il Papa si era preparato alla ripresa delle ostilità fin dal 4 ottobre '96, quando aveva chiamato a raccolta i sudditi «a difesa dei suoi Stati». Il 12 ottobre il cesenate Cardinal Gregorio Barnaba Chiaramonti (il futuro Pio VII), era fuggito da Imola, sua sede episcopale, «per timore di rimanere catturato nelle mani de' Francesi». Il 14 era iniziato il passaggio per Rimini dei dragoni pontifici diretti a Faenza.
Il 16 ottobre per volontà di Napoleone si era riunito a Modena un Congresso con i rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, deliberando la fondazione della Confederazione Cispadana. Lo stesso Congresso il 17 ottobre aveva diffuso l'invito ai popoli della Romagna di unirsi ai Liberatori e di aderire alla Confederazione. Esaltando il governo della Chiesa come ispirato alla libertà, i papalini risposero: «Noi ambiamo il suffragio vostro: noi dispregiamo quello dei vostri Oppressori», cioè dei francesi.
Il 18 ottobre a Rimini era pervenuta la notificazione pontificia spedita a tutti i Governatori delle province per una nuova difesa dello Stato della Chiesa. Lo stesso giorno, mentre a Bologna veniva piantato l'Albero della Libertà e s'incendiava una caserma dei birri, Pio VI «per li nuovi sospetti o minacce dell'armi francesi allo Stato Pontificio», ordinava «guerra difensiva ai suoi sudditi». E da Forlì cominciava in tutta la Romagna la cattura dei giacobini, trasferiti il 19 a Rimini e di lì nel forte di San Leo. La repressione colpiva intellettuali, professionisti e parecchi nobili.
Torniamo al febbraio 1797. Il 3 febbraio, all'indomani dell'attacco francese a Faenza e dopo la fuga da Rimini a San Marino del Vescovo Vincenzo Ferretti e del Governatore Luigi Brosi, e mentre le famiglie più ricche e distinte si trasferiscono nelle loro proprietà in campagna, l'ex conte Nicola Martinelli si attiva per far assumere dal nostro civico Consiglio i provvedimenti necessari a non lasciare la città in balìa di se stessa e per prevenire danni e disordini dell'invasione.
Il giorno 4 Napoleone crea l'Amministrazione Centrale della Legazione di Romagna, stabilendola a Ravenna: di essa fanno parte nove persone, tra cui lo stesso Nicola Martinelli. Avvenuta l'occupazione di Rimini, Martinelli nella sua veste di presidente della Municipalità difende gli interessi della città. Il 4 aprile non cederà alle pesanti richieste economiche del generale Victor Perin che si rifarà della sconfitta saccheggiando Santarcangelo. A Martinelli, che da un trentennio è tra le figure di spicco della vita pubblica locale, andranno lodi e ringraziamenti per aver coraggiosamente salvato le sostanze dei suoi concittadini.
Rimini è infatti una città impoverita dagli eventi bellici. Nel luglio '96 ha dovuto pagare alla Repubblica francese 64 mila scudi di contribuzione. Poi le è stato imposto di partecipare alle spese per le truppe che il Papa ammassava in attesa di riprendere il conflitto. Adesso ci sono le nuove, pesanti pretese degli invasori. La situazione è insostenibile.
Napoleone arriva in città nella notte sul 6 febbraio, ospite di Gian Maria Belmonti Stivivi, uno dei tanti nobili filogiacobini che vedono nell'occupazione francese un mezzo per scalzare il dominio papale. Prima di ripartire alla volta di Pesaro, Bonaparte arringa i parroci: la rivoluzione non minaccia la religione, stiano quindi tranquilli loro, e mantengano calmi i loro fedeli. Napoleone ha già avvertito: il nuovo governo della Romagna, posto alle dipendenze della Cispadana, avrebbe preso «tutte le misure necessarie per reprimere i falsi Preti, che si allontanassero dai principj della vera Religione, e che volessero frammischiarsi negli affari temporali».
Bonaparte si illude che, facendo tacere il clero, si possa tenere a bada la plebe. Il malcontento che serpeggia nei quartieri poveri della città, nelle parrocchie di periferia o nelle campagne, non ha bisogno di essere alimentato da tante prediche. È dall'inizio del secolo che qui passano truppe, si richiedono esborsi in denaro e si ordinano requisizioni allo scopo di alimentare i soldati ed i loro animali. Per esperienza dolorosa tramandata di padre in figlio, la gente sa che ogni esercito, amico o nemico, porta fame e distruzione dove transita o si accampa.
I torbidi non iniziano con il «Governo Francese», come la nuova situazione politica viene definita nei registri comunali di Rimini alla data del 5 febbraio. Nel mese precedente sono già avvenute violenze attribuite a «forusciti, tra quali sono stati veduti anche di zingari». Con la parola «forusciti» si indicavano esuli politici filofrancesi che tramavano contro il potere romano. Il loro comportamento è più da briganti da strada che da veri cospiratori politici contro l'ordine costituito: essi «e di giorno, e di notte vanno alla Case, e non solo contenti di mangiare, e bere, portano via ciò che possono avere: polli, agnelli, panni, ed anche ori e denari se ne ritrovano». Ad un contadino «dopo averli tolto trenta pavoli, e tre miserabili anelli d'oro, che facevano tutta la sua sostanza, lo regalarono di alcune giuncate». Ad un altro, «dopo averli bevuto una quantità di vino, li amazzarono sino una scrofa pregna, e così hanno fatto a molti altri». Quei poveri lavoratori della terra si trovavano di conseguenza «in grandissima agitazione». Nei paesi di campagna, il popolo è «stato eccitato alla diffesa» prima che arrivassero i francesi.
Appelli di aiuto alla Municipalità riminese giungono anche da amministratori e parroci di località vicine. Non ci sono i mezzi per porre riparo ai mali che vengono denunciati: «Ci mancano cavalli, ed armi per far batter la Campagna dalla Guardia Civica». A tre parroci del contado, si comunica il piano stabilito dalla Municipalità di concerto con il Comandante francese della Piazza di Rimini «per rimediare efficacemente e sollecitamente ai disordini, che si commettono dai Forusciti nelle Campagne»: istituire una Guardia Civica nelle «Ville del Bargellato», agli ordini di un militare francese, «affine di fare il giro notte e giorno delle rispettive Parocchie per arrestare, e condurre in Città que' Vagabondi, che fossero trovati fuori della Strada Maestra, o Consolare per fare del male».
I parroci avrebbero dovuto collaborare inviando «dieci uomini di coraggio», che sarebbero stati «spesati per tutto il tempo, che presteranno il servizio». La Municipalità garantisce che essi non sarebbero stati «mai né offesi, né reclutati», secondo le assicurazioni ricevute dallo stesso Comandante repubblicano della Piazza di Rimini.
La parola «forusciti», usata prima dell'arrivo dei francesi per definire i loro sostenitori alla macchia, ritorna ora per indicare i partigiani del Papa. Essa s'accoppia al termine «vagabondi», meno preciso, anzi decisamente più ambiguo e quindi perfettamente adatto a quei momenti.
In qualche località, «per le vessazioni e ruberie, che si commettevano, e si commettono», sono accusati «malviventi, e vagabondi, che hanno seguita, e seguono l'Armata Francese». Il «Cittadino Lapisse Comandante della Piazza di Rimini» fa sapere: «né soldati, né Ufficiali Francesi, o chiunque altro, possono pretendere, e molto meno esiggere dagli osti, ed abitanti nessuna sorte di viveri, foraggi, o altra cosa senza l'esatto, e puntuale pagamento, giacché la truppa riceve le Razioni necessarie pel suo camino».
In realtà il comportamento degli occupanti non si ispira alle regole ricevute, se lo stesso Bonaparte il 7 febbraio scrive ai suoi soldati: «Non mi trovo contento di voi», e minaccia di passare per le armi chi avesse «strapazzato, o attentato in verun modo, sia nella Persona, sia nella Proprietà del Popolo vinto», o avesse con sé «roba rubata».
I nuovi padroni della città per difendersi considerano ogni reazione alle loro prepotenze come frutto di trame occulte ordite per garantire organizzazione ed impunità ai «vagabondi»: e così, ricorrono alla storia dei «falsi Preti» che volevano «frammischiarsi negli affari temporali», sobillando alla sollevazione l'ingenuo popolo.
Gli ecclesiastici locali sono obbligati ad obbedire agli ordini del Pontefice per la «più valida resistenza, e difesa» nel caso di tentativi d'invasione, come si legge in un documento apparso senza firma e senza data a Rimini il primo febbraio '97, ma attribuibile al Vescovo Ferretti.
I Vescovi in un primo momento credono di trovarsi a combattere eroicamente una nuova crociata (il Papa pretendeva una semplice guerra), mentre si trattava soltanto di una battaglia politica in cui occorreva comportarsi con la stessa spregiudicatezza dell'avversario. Anche prima che il 19 febbraio 1797 Repubblica francese e Stato della Chiesa firmino la pace di Tolentino (con la quale il Papa deve cedere la Legazione di Romagna), essi passano dagli appelli insurrezionali ai compromessi per non agitare le città sottoposte al dominio napoleonico.
Nel 1796, dopo l'ingresso del francesi a Bologna, il Vescovo Ferretti aveva indirizzato il 24 giugno a tutti i parroci della Diocesi di Rimini una circolare, con la quale gli ordinava di esortare i fedeli alla quiete ed alla rassegnazione. Nello stesso giorno il Cardinal Legato aveva avvisato il Governatore di Rimini «d'esser imminente l'avvanzamento» di un corpo di truppe francesi, da accogliere «in adempimento delle sovrane intenzioni di Nostro Santità», provvedendolo «di alloggi, di viveri, e di foraggi». Il Governatore era anche sollecitato a mantenere tranquillo il popolo.
Se impresa difficile era già rimediare i rifornimenti per i militari, impossibile addirittura appariva quella di convincere i fedeli, anzi i sudditi, che per loro non si profilava nessun pericolo. La fuga dello stesso Legato il 26 giugno da Ravenna a Rimini, dove sostò prima di ripartire per Pesaro, dimostrava che le ipotesi ottimistiche erano chimere usate per ingannare la pubblica opinione.
Si ordinò poi di deporre le armi da fuoco e di non indossare divise militari, cercando di prevenire accensioni di fiamma. Queste decisioni giungevano ormai in ritardo sugli eventi militari (con la tregua del 23 giugno il comandante francese s'impegnava a sgomberare la Legazione di Ravenna), ma in tempo per prevenire la mossa del generale Augerau che il 26 giugno scendeva in Romagna cercando di conquistarla democraticamente con una specie di referendum: preferite la Francia o il Papa? La mossa di Augerau era in contrasto con l'armistizio.
All'apparire dei francesi in Emilia, nessuno si era preoccupato di dare ordini alle nostre città: «Nelle attuali critiche circostanze siamo privi fin ora d'Istruzioni per parte dei Signori Supperiori, né per ciò abbiamo potuto fissare verun piano che riguardi la pubblica salvezza e tranquillità». È una lettera della Municipalità di Rimini datata 21 giugno 1796: «Quello solo che abbiamo creduto non dovere omettere è di procurare l'espulsione dalla Città nostra de vagabondi esteri mediante una Patulia di Soldati della prima Compagnia dell'infanteria, e la provvista della maggior quantità di farina, che sia stata possibile». Lungimirante l'idea di procurar cibo, ma convenzionale quella di prendersela con i «vagabondi esteri» come primo capro espiatorio nell'emergenza provocata da Bonaparte.
Il 24 giugno seguiva una lettera riminese al Legato, il quale nel frattempo aveva avvisato il nostro Governatore dell'avanzarsi dei francesi. La Municipalità chiedeva lumi su come comportarsi: l'invasione ed il ritiro delle truppe pontificie dalla Romagna, avevano «prodotto in tutti i Concittadini un sordo mormorio che indica l'universale timore, e costernazione, dimodocche si è fino durata fatica impedire l'emigrazione di molti degli abitanti del Porto. Questa costernazione chiaramente ci manifesta, che le provvidenze da noi date fin qui non contentano abbastanza la popolazione, e ci fa conoscere necessari altri più efficaci provvedimenti». Come ad esempio l'invio di una «Deputazione ai Comandanti Francesi per renderli con questo passo più umani, più dolci, più premurosi col nostro Popolo».
La Municipalità si preoccupava di spiegare al Legato che la proposta non intendeva essere «un atto di deffezione dalla S. Sede», e che si voleva la di lui approvazione per «tutto quello che faremo, o saremo per fare in così critica, e dolorosa circostanza»: «desideriamo anzi, che per questo passo non divenga giammai per verso Vostra Eminenza sospetta la Fedeltà, l'Amore, l'attaccamento di Noi, e di questo Popolo per il nostro Sovrano».
In base all'armistizio, il governo pontificio, cioè il suo popolo, avrebbe dovuto sborsare una contribuzione complessiva di 21 milioni di lire. Per il bene della pace. E senza tante storie: «Ora non è tempo di sorpresa, ma di azione. Si minaccia da un'Armata vittoriosa il Sacco generale se immediatamente non si contribuisce quanto essa dimanda», scrive la nostra Municipalità.
Non tutto il popolo gradiva: la campagna era «infestata da Forusciti». Era il 30 giugno. Nello stesso giorno giungeva alla nostra Municipalità la notizia «di una insurrezione popolare a Cesena la quale dicesi vada dilatandosi nei convicini Paesi». Il 1° luglio partiva da Rimini alla volta del Gonfaloniere di Pesaro un «Avviso di generale tumultuazione»: «Ieri sera giunsero in questa città sopra venti persone di Forlì che si credono quelle che hanno eccitato il tumulto popolare in Cesena. Qui pare cominciavano a sollevare la Gente: ma noi col mezzo della Guardia Civica ne li abbiamo espulsi, per non aver come ritenerli». Molti di quegli insorti si erano incamminati verso Pesaro.
A Cesena, scrisse don Gioacchino Sassi, il 29 giugno successe un «grandissimo disturbo» per una sommossa di sessanta «Patriotti» che «volevano impedire al pubblico a ciò non dassero la contribuzione alli Francesi» (40 mila scudi in denaro). Soltanto alla sera, al secondo tentativo, al Vescovo di Cesena era riuscito di fermare i rivoltosi: «i cattivi deposero le armi. Alcuni forastieri, e fra questi molti forlivesi, erano venuti in Cesena chiamati dai suddetti sollevati quali fu gran fatica a rimandarli alla loro terra». Il 30 giugno ci fu l'assalto al carrozzino dell'aiutante del generale Verdier, con la sua cattura: quando per ottenerne la liberazione il generale Augerau minacciò il sacco a Cesena, quell'aiutante era già stato rilasciato.
Per paura dell'imminente arrivo dell'armata francese, «una gran parte de' buoni cittadini si darono alla fuga dalla città andandosi a ricoverarsi sui più alti monti», imitati dai villani che abbandonarono la cura dei campi e se ne fuggirono «chi da una parte chi dall'altra». Tutta colpa dei giacobini italiani e delle loro «secrete intelligenze» con il nemico, secondo don Sassi. Chi era rimasto in città, se ne scappò all'arrivo dei soldati di Napoleone, seguendo l'esempio del rifugio «sulle più alte montagne». Un mugnaio «fuggendo precipitosamente schioppò sulla strada di San Marino».
Il 4 luglio era stata consegnata ai francesi la contribuzione della città di Rimini. Il 26 giugno si era avvertito il popolo con una notificazione, in cui, garantendo che le truppe francesi avevano fino ad allora rispettato Religione, proprietà e persone, si raccomandava «al Popolo di rimanere quieto, e di conservare tutto il buon'ordine per non esser egli stesso responsabile di quanto potesse avvenire, e per di lui colpa, di cui si esigerebbe la più rigorosa ragione». Il 28 giugno un «Avviso» del Segretario municipale rendeva noto ai «generosi Cittadini» che per la consegna di ori ed argenti richiesti dai francesi, la Comunità riminese avrebbe corrisposto un frutto del cinque per cento.
Il 7 luglio le truppe di Augerau avevano messo a ferro e a fuoco e saccheggiata la città di Lugo, ribellatasi ai francesi ed anche all'appello alla moderazione del vescovo di Imola, Cardinale Chiaramonti. Per tutta la Romagna si erano sparse le popolazioni in fuga (gente di ogni sesso e condizione, e turbe di contadini raccapricciati dallo spavento), giungendo anche a Rimini, per andar verso Pesaro o alla montagna.
Si ebbe paura che qualcosa di simile potesse capitare anche alla nostra città. Un «falso allarme» aveva indotto «i Contadini delle vicine Campagne, e gli Abitanti de' Luoghi limitrofi ad abbandonare le rispettive Case, ed incombenze»: la «Pubblica Rappresentanza» il 9 luglio si era preoccupata di avvertire con una notificazione molto diversa nei toni da quella appena ricordata del 26 luglio, che «i Popoli amutinati, incapaci di resistere alla forza dell'Armata Francese, hanno dovuto cedere colla perdita del proprio sangue, col sagrifizio della Patria, e delle proprie sostanze». Occorreva stare «nella dovuta rassegnazione», senza dar «corpo a sospetti», nella «lusinga di veder quanto prima evacuata questa Provincia di Romagna dalle Truppe Francesi».
Il Cardinal Legato aveva fatto ritorno a Ravenna il 18 luglio. Tutto dunque era tranquillo? «La corte di Roma», secondo il faentino don Saverio Tomba, «uditi i vantaggi degli Austriaci sul Reno conseguiti, e l'accrescimento delle forze imperiali verso l'Italia, che davano risoluti segni di voler recuperare gli Italiani possedimenti, cominciò a detestare gli umilianti articoli della tregua come nei giorni dello spavento li aveva prudentemente ricevuti». In settembre il governo del Papa aveva appreso di «un tradimento tramato dai francesi» ed aveva rotto le trattative di pace in corso con Parigi a Firenze, cercando di «stabilire a Vienna un trattato di alleanza». Napoleone aveva minacciato: «Infelici Ravenna, Faenza, Rimini».
Il resto lo abbiamo già raccontato: il Pontefice chiamava a raccolta i sudditi «a difesa dei suoi Stati» ed ordinava «guerra difensiva», nell'attesa che a rompere la tregua fosse la tracotanza francese. Allora, segretamente, anche nella Diocesi di Rimini ci si preparò al mutamento della situazione. Si poté così far affiggere la mattina del primo febbraio '97 un piccolo manifesto che, prevedendo l'evoluzione dei fatti, era stato redatto e fatto comporre dal tipografo in tutta tranquillità: il foglio è senza firma e senza luogo di stampa, oltre che senza data, ma (come già si è detto) viene attribuito al Vescovo Ferretti. Il testo lungo e meditato, non un semplice proclama buttato giù a tambur battente, richiama le posizioni assunte dal Pontefice il quale «non dubita, che li suoi sudditi proseguiranno ad essere animati da que' sentimenti di fedeltà, di attaccamento, e di coraggio, che con tanta gloria han dimostrati sin'ora».
In caso d'invasione francese, secondo il volere del Santo Padre, i sudditi avrebbero dovuto apprestarsi «alla più valida resistenza e difesa». Il Papa garantiva che si sarebbe opposto all'avanzata napoleonica «con tutte quelle forze, ed in quella più energica maniera, che gli sarà possibile». All'occorrenza, secondo le disposizioni romane, precisava il manifesto, si sarebbe suonata campana a martello, ed i cittadini avrebbero preso l'armi, levandosi in massa, a coadiuvare la «Truppa Regolata», e ad «affrontare il Nemico con quel coraggio, e con quel valore, che ispira ad un Cattolico la Fede, ad un buon Cittadino l'onor della Patria, ed all'uomo la conservazione di se stesso, e di quanto ha di più caro sù questa Terra».
Dopo la fuga del Vescovo, avvenuta all'alba del 2 febbraio, a guidare la Chiesa riminese è rimasto il canonico Filippo Baldini, pro Vicario Generale, che la sera dello stesso giorno è costretto dalla Municipalità a firmare una dichiarazione di smentita del proclama apparso quella mattina: «In mancanza di monsignor Vescovo io qui sottoscritto dò autorità all'ill.mo Magistrato di far sapere a tutti li Parochi, e Conventi di tutta questa Diocesi di non toccar campana a martello per l'unione di popolo armato senza ordine preciso del suddetto Ill.mo Magistrato o di me sottoscritto».
La stessa sera il Segretario della Municipalità pubblica questa «Notificazione»: «Rimane ora abbandonata la nostra Città dai Signori Superiori [Governatore e Vescovo], che providamente la reggevano. Appartiene perciò alla Pubblica Rappresentanza di prenderne le redini, ed ai buoni Cittadini di prestarsi generosamente ai suoi bisogni». Era il classico vuoto di potere in cui tutto era possibile. Il primo provvedimento che la «Notificazione» suggerisce è di costituire subito, per la comune tranquillità, una Guardia Civica volontaria.
Il giorno 3 il pro Vicario Generale invia ai parroci questa lettera: «Nelle attuali critiche circostanze non essendovi cosa, che più interessi la salvezza della Patria, e de Cittadini quanto la tranquillità, né che più la esponga a pericolo di un ardore intempestivo, di cui altrove ci sono intesi i perniciosi effetti, nell'assenza dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Vescovo ma colle debite autorizzazioni dichiaro di non dovere [cancellato a penna: «per ora»] aver alcun effetto, il Proclama divulgato per l'unione di gente armata al tocco di Campana a martello, ed espressamente proibisco detto segno a chiunque in qualsivoglia caso senz'ordine mio preciso in iscritto sotto le maggiori pene».
Implicitamente si riconosceva che il «Proclama divulgato» proveniva da fonte autorevole e non da orditori di trame di rivolta che, in caso contrario, sarebbero stati chiamati in causa ed additati al pubblico disprezzo. Il canonico Baldini anticipa le direttive che il 4 febbraio l'Arcivescovo di Ravenna impartisce a tutti i Vescovi della Provincia: adoprarsi con una lettera pastorale per insinuare «sentimenti di tranquillità e di pace» in tutto il clero e nei fedeli. Il canonico Baldini, il segretario municipale e soprattutto l'Arcivescovo di Ravenna usano la parola «tranquillità» più come auspicio che come termine capace di indicare la condotta da adottarsi in momenti così terribili.
Intanto i francesi avvertono i romagnoli che hanno versato «soccorsi» al Papa «per continuare una guerra» che li avrebbe condotti alla totale rovina: la Repubblica pretende da loro subito metà della stessa cifra, con l'impegno di pagare l'altra metà «di qua ad un mese».
Dopo i «felici successi delle Truppe Francesi contro gl'Insorgenti Montanari» alla fine di marzo, Martinelli ha polemizzato: fu soltanto «l'affare di mezz'ora» l'attacco a Santarcangelo contro un'«orda di banditi», la cui azione, «ultimo sforzo della Romana debolezza», «non merita l'onore della nostra paura». La Giunta di Difesa della Cispadana accusa Martinelli di essere sempre stato uno sfrontato doppiogiochista: «voi antico Calunniatore del Governo [romano], e deciso fautore di tutte le novità», siete stato sempre protetto e favorito; «quando tutta la Romagna sapeva, che voi eravate alla testa di tutti i complotti, adunanze, conventicole contro il Principato; quando i Superiori n'erano informati; quando il popolo, perfino le Donnicciuole vi mostravano a dito, come il nemico del Governo Pontificio; voi pacificamente ve ne stavate in casa sicuro del fatto vostro: in tempi di pericolo, e di qualche energia del Governo contro i Novatori voi trovaste il modo di salvarvi ad onta delle declamazioni, che facevate fare dai Neofiti vostri».
Con segreti maneggi ed opportune raccomandazioni mentre dirigeva «operazioni arcane», Martinelli ha evitato «processi ben meritati». Egli è stato il maggior nemico del Principato, un seduttore del Popolo, un segreto macchinatore di novità nel Governo: «I Superiori della Provincia lo sapevano, lo vedevano, lo toccavano con mano: ognuno si meravigliava, che voi respiraste impunemente l'aria della vostra patria da voi corrotta e nella massima e nel costume: nei giorni, che vi accovacciavate per timore di essere scoperto, e per avere ozio sicuro ad oggetto di deludere l'altrui vigilanza, come nei giorni, che persuaso della vicina vostra risurrezione radunavate il vostro consiglio, e presiedevate alla Loggia rustica». Questo accenno alla «Loggia rustica» pare indicare in Martinelli un esponente della Massoneria: nella quale si potrebbe ipotizzare la garante di tutta l'attività politica svolta dal conte riminese e che non risultava gradita alla Giunta di Difesa. Il dissidio tra la Giunta e Martinelli potrebbe infine confermare l'esistenza di due anime all'interno del movimento giacobino locale.
Certo è che, prima della conquista napoleonica, Martinelli aveva potuto viaggiare tranquillamente fra la Romagna papalina e la Cispadana, mantenendo ottimi rapporti con il Legato e con i francesi. Nello stesso '97, nonostante le pessime notizie che circolano sul suo conto, diventa presidente dell'Amministrazione Centrale romagnola, e Seniore del Dipartimento del Rubicone nella Cisalpina, oltre che candidato alla prestigiosa carica di ambasciatore presso la Corte di Vienna, che non accetterà per motivi di salute.
Mons. Ferretti ritorna segretamente a Rimini il 13 aprile, dopo essersi aggirato ed occultato per le montagne vicine, ma viene subito arrestato nella sua Residenza, ove se ne sta rinchiuso per più giorni. A liberarlo ci pensa il Generale Comandante della provincia, Sahuguet, a cui il Vescovo offre un suntuoso banchetto per ringraziamento e per evitare ulteriori fastidi.
1797, i francesi a Rimini, «Pagine di Storia & Storie», III, 7, supplemento a «Il Ponte», Settimanale cattolico riminese, XXII (1997), 7, pp. 1-8.
Sull'argomento cfr. Fame e rivolte nel 1797. Documenti inediti della Municipalità di Rimini. Saggio di Antonio Montanari
-
Par riministoria le 26 Mai 2013 à 16:22

Nel 1964 a Stoccolma Margareta Giordano Lokrantz (1935-2004) pubblica "L'opera poetica di S. Pier Damiani", contenente la descrizione dei manoscritti e la loro edizione. Tra i componimenti più famosi, c'è il n. XCIX, ovvero il "Bennonis Epitaphium", come è intitolato nella "Opera omnia" apparsa "Parisiis, Sumptibus Caroli Chastellain, MDCXLII", e riedita nel 1743 sempre a Parigi.
Rimini, piangi
Eccone il testo completo (ed. 1964): "Ariminum, luge, lacrimarum flumina funde;/ Laus tua Benno fuit, pro dolor ecce ruit./ Benno decus regni, Romanae gloria genti,/ Ipse pater patriae, lux erat Italiae./ Hunc socium miseri, durum sensere superbi;/ Lapsos restituit, turgida colla premit./ Fit leo pugnanti frendens, tener agnus inermi;/ Hinc semper iustus perstitit, inde pius./ Hic fidei dum iura colit, dum cedere nescit,/Firma tenens rigidae pondera iustitiae,/ Reticolae iugulus prauorum pertulit ictus./ Per quem pax uiguit, bellica sors perimit./ Obsecro, tam diram sapientes flete ruinam/ Et pia pro socio fundite uota Deo".
Il v. 12 è edito da Lokrantz come "per quem pax uiguit, bellica sors perimit", anziché il classico "bellica sors periit", per cui abbiamo: "la guerra uccise colui per merito del quale fiorì la pace" (anziché "per lui fiorì la pace, la guerra cessò"). Questa traduzione è contenuta in un testo pubblicato nel 1965 dal prof. Scevola Mariotti, in cui si ricorda come la nuova lettura del v. 12 offerta da Margareta Lokrantz, comporti conseguenze "di ordine storico". Mariotti precisa: "…a quanto pare, Bennone fu ucciso in un fatto di guerra". D'ora in avanti chiamiamo Benno il personaggio detto Bennone da Mariotti, seguendo lo stesso Pier Damiano che inizia così l'epitaffio: "Ariminum, luge, lacrimarum flumina funde; / Laus tua Benno fuit".
Luce dell'Italia
L'accenno contenuto nell'epitaffio sarebbe l'unica testimonianza pervenutaci di lotte locali tanto violente da giungere all'uccisione di un capo politico cittadino. Benno infatti è definito da Pier Damiano "onore del regno, gloria della stirpe romana, padre della Patria, luce dell'Italia" ("Benno decus regni, Romanae gloria genti, / Ipse pater patriae, lux erat Italiae", vv. 3-4). Padre della Patria o della città era chiamato il rappresentante della vita municipale che doveva vegliare alla difesa del Comune sotto il dominio della Chiesa romana. Era una figura ben distinta dal Conte, il quale era un delegato pontificio od imperiale. Uomo giusto e pio, severo con gli oppositori ma dolce con gli indifesi, Benno è quindi dato da Pier Damiano per ucciso nel corso di una "guerra": "lui, per merito del quale fiorì la pace", fu forse vittima di una lotta sulla cui origine possono essere avanzate soltanto ipotesi, connesse al ruolo politico svolto dallo stesso Benno.
Uomo di fede e difensore degli interessi della Chiesa (altrimenti Pier Damiano non l'avrebbe glorificato), mentre la feudalità laica mirava ad una sostanziale autonomia politica ed aumentavano i sostenitori dell'indipendenza cittadina, Benno probabilmente non riuscì a pervenire ad una sintesi originale tra mondo laico ed ecclesiastico, per conciliare gli interessi "particulari" cioè cittadini con quelli della sede di Pietro.
I riminesi possono aver visto in Benno un capo che finiva per essere più il rappresentante del Pontefice (come il Conte) che della loro stessa comunità. E quindi possono aver cessato di considerarlo come un'espressione della giustizia e dell'equilibrio nei rapporti fra la città e Roma. Nell'additarlo pubblicamente come traditore, sarebbe stata così scritta la sua condanna a morte. Portata ad esecuzione nell'anno stesso della fondazione del monastero di San Gregorio in Conca, il 1061.
Antonio Bianchi
Delle lotte precomunali a Rimini si occupa Antonio Bianchi all'inizio del cap. 12 della sua "Storia di Rimino dalle origini al 1832", come necessaria introduzione alla raccolta delle notizie elencate in successione cronologica: "Se la prima metà di questo secolo non fu totalmente pacifica pel nostro paese, peggiore di molto dovett'essere l'altra metà, giacché alleggeritosi in Italia il predominio dell'autorità imperiale, crebbe talmente lo spirito d'indipendenza, che ogni città, ogni vescovo ed ogni conte, insomma qualsiasi persona potente, che avesse mezzi da sostenersi voleva farla da padrone assoluto…".
Bianchi scrive sul ruolo del "pater civitatis": "Oltre i conti, altra autorità esisteva nelle nostre città col titolo di "pater civitatis", che doveva essere il capo della magistratura civile; il più antico di cui ci sia rimasta memoria è un certo Bennone, morto fra il 1028 e il 1061; del medesimo abbiamo un pomposo elogio scritto da San Pier Damiano, il quale aveva ottenuto dallo stesso Bennone e da altri di sua famiglia molti terreni, sopra uno dei quali fabbricò il monastero di San Gregorio in Conca, che nel 1071 lo stesso San Pier Damiano mise sotto la protezione del vescovo di Rimini e dei suoi successori. Molto ricca e potente era la famiglia di quel Bennone, possedendo castelli e molti terreni", come si ricava dai documenti pubblicati dal canonico Angelo Battaglini nel 1783.
Sotto l'anno 1060, Bianchi osserva: "Goffredo duca di Toscana […] fa eseguire un concordato fra l'abbate di Pomposa ricorrente contro alcuni ivi nominati, i quali promisero di non recare alcuna molestia tanto nelle persone che ne' beni di detta abbazia esistenti nel Contado di Rimini: vi erano presenti, fra molti altri" il vescovo di Rimini e due giudici della stessa città, uno dei quali è "Petrus de Benno", ovvero Pietro figlio del Benno da cui siamo partiti. Nel 1060 il Pater Civitatis ricordato è Bernardus. Pietro figlio di Benno è divenuto celebre per un'altra donazione del 1069 a favore dello stesso Pier Damiano. Nel 1070 Pier Damiano dona il monastero di San Gregorio in Conca al Vescovo di Rimini.
Battaglini e Tonini
Nelle "Memorie istoriche di Rimino e de' suoi signori" pubblicate da Francesco Gaetano Battaglini (fratello di Angelo) a Bologna nel 1789, leggiamo un ricordo sia di Benno ("Bennone di Vitaliano") sia di suo figlio Pietro. Battaglini osserva su Benno che non si può "credere, che ad un uom sì giusto, e sì reputato, e che pel governo da sé fatto meritò encomio sì degno, fosse prima di sua morte tolta di mano la bilancia della giustizia".
Carlo Tonini (1835-1907) nel primo volume del suo "Compendio della Storia di Rimini" (1895), presenta una pagina del tutto originale. Dall'elogio che ne fa Pier Damiano, "risulta chiaramente che questi fu un intrepido e sapiente amministratore di pubblica giustizia; quanto mite e pio verso i miseri, altrettanto rigido e severo coi superbi […]. E non potrebbe forse inferirsi da ciò, che ei cadesse vittima delle vendette d'alcun nemico potente, che avesse provato i rigori di quella sua cotanta ed inflessibile giustizia? E non varrebbe per avventura a confermarci in questo sospetto segnatamente il penultimo verso dell'elogio – Obsecro tam diram sapientes flete ruinam? A noi pare che il Damiani non avrebbe usata una simile espressione, se il grand'uomo fosse morto placidamente nel suo letto e nella pienezza de' giorni suoi".
Tonini ricorda: Damiano scrive di Benno che "pravorum pertulit ictus". Il problema non è, come è stato scritto, di dare una "versione più neutra, che esclude ogni riferimento a effettive vicende politiche riminesi" nella traduzione dell'epitaffio. Ma d'intendere il senso di quello che si legge nel passo così ben spiegato da Tonini: "pravorum pertulit ictus". Tonini cominciò a dubitare che "il grand'uomo fosse morto placidamente nel suo letto". Non si possono scrivere le storie di quei momenti ignorando le pagine di chi se ne è già occupato, addirittura nel 1895, con una prospettiva innovatrice per interpretare i fatti e le figure di cui si parla.
Lena Vanzi
Sul tema:
Chiesa riminese, storia. Quel secondo volume... (2012)
Benno trascurato? Una risposta (2012)
Benno trascurato come al solito (2010)
Rimini 1061, una guerra dimenticata, saggio integrale inedito [26.05.2013]
-
Par riministoria le 3 Mars 2013 à 17:11
L'affascinante ricerca delle fonti storiche a conferma della lapide di San Martino
1231, Federico II e gli elefanti
["il Ponte", n. 9, 03.03.2013]Nel 1516 la cattedrale di Santa Colomba, nella cappella della Madonna Incoronata, restituisce il corpo di una donna, avvolto in un prezioso panno. Nel quale si legge soltanto il nome di Federico imperatore ed una data, 1231. La prima notizia sul panno è pubblicata da Raffaele Adimari nel "Sito Riminese" (Brescia, 1616, p. 59). Nella cattedrale, egli precisa, "vi è un drappo antichissimo di seta [...] che si vede esser stato fatto nel Anno M.CCXXXI. il qual fù trouato in un'arca di Marmo [...] il qual dicono, che fù posto in quel luoco da Federico II. Imperatore, inuolgendoli dentro una sua Figliuola morta".
Nel "Raccolto istorico" di Cesare Clementini (Rimini, II, 1627, p. 664), troviamo più particolari: "fabbricandosi nella Cattedrale la Capella chiamata l'Incoronata, hora di San Gioseffo, [...] dentro l'antico muro della Chiesa, fu trovato una Donna morta, e avolta in un regio panno di seta rossa, lungo braccia sei, ripieno di Rosoni d'oro, e di Leoni, fatti a basso rilievo parimente d'oro, che sostengono un gran fiore, attorniato con certi circoli, in mezzo a quali stanno alcune lettere, che per esserne una parte corrosa, altro non si legge, che FRIDERICUS Imp. Aug. MCCXXXI".
La "morta Donna"
La pagina di Clementini prosegue con l'ipotesi circa l'identità della "morta Donna". Secondo alcuni è una Baronessa, secondo altri una Nipote di Federico II. Adimari, come abbiamo visto, invece parla di una Figliuola dell'imperatore: la sua fonte è un trattato sul vermicello della seta (Rimini, 1581) composto da Giovanni Andrea Corsucci da Sassocorvaro, già rettore di San Giorgio Antico e Maestro comunale. Corsucci annota pure che ai suoi tempi l'antico panno funebre era ancora fresco e bello, e che se ne serviva il Capitolo della Cattedrale per il cataletto nei mortorii di Vescovi e Canonici, nel portarli alla sepoltura.
Chi può essere la Donna morta? Il padre di Federico II, Enrico VI, ha un fratello Ottone II che da Margherita di Blois genera Beatrice di Borgogna, moglie di Ottone il Grande. Questa Beatrice scompare proprio nel 1231, il 7 maggio, l'anno del funerale riminese. Ma si trova poi che essa è sepolta dal dicembre dello stesso 1231 nell'abbazia di Langheim a Bamberg. Quindi sarebbe da escludere che sia suo il corpo ritrovato nel 1516.
Beatrice era un personaggio troppo importante per essere eventualmente lasciata lontana dalla propria patria. La presenza di Beatrice in Romagna non sarebbe strana. Basti ricordare quanto scrive Carlo Sigonio (1520/23-1584) nel XVII libro della sua storia del Regno d'Italia (1591): Federico II chiamò dalla Germania in Romagna il figlio Enrico ed i suoi principi. Tra costoro c'è pure il marito di Beatrice, Ottone I d'Andechs e di Merania.
Feste per tutti
Sigonio aggiunge: Federico II, per non intimorire la gente con parate militari anzi per allietarla e divertirla, organizza una sfilata di animali mai visti o poco noti da queste parti. Sono appunto gli elefanti, leoni, leopardi, cammelli ed uccelli rapaci che per molti giorni offrono meraviglioso spettacolo e che finiscono citati nella lapide ritrovata a San Martino in Venti (1973-74), come ha raccontato Anna Falcioni in un testo edito da Bruno Ghigi nel 1997.
Sul Ponte (4.5.2008) lo ha presentato Angela De Rubeis: "Mentre si lavorava all'abbattimento di un circolo ACLI che nel dopoguerra era stato costruito con le macerie lasciate sul campo dai tanti bombardamenti, si scopre quella lapide che il parroco don Lazzaro Raschi conserva indagando sulla sua antica collocazione”. Trova così che prima degli anni '40 essa "era posta, e ammirata dai fedeli, sotto l'altare maggiore" della sua chiesa, in quanto considerata una pietra sacra.
Nell'articolo si ricorda la serie degli studi per "leggere" quella pietra, iniziati da Augusto Campana, proseguiti da Gina Fasoli e completati da Aurelio Roncaglia (1982) con questa traduzione: "Nell'anno del Signore 1231, sotto il papato di Gregorio e l'impero di Federico [...] al tempo in cui l'imperatore Federico venne a Rimini e condusse con sé elefanti, cammelli e altri mirabili animali, quest'opera fu fatta e completata".
Mainardino, la fonte
Il passo di Carlo Sigonio fu riproposto da Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) negli "Annali" (VII, Napoli, 1773, p. 209) senza la precisazione della fonte: "l'avrà preso da qualche vecchia Storia. Cioè, che Federigo diede un singolare spasso a i popoli in Ravenna, coll'aver condotto seco un liofante, de i leoni, de' leopardi, de' cammelli, e degli uccelli stranieri, che siccome cose rare in Italia, furono lo stupore di tutti".
La fonte di Sigonio è Mainardino Imolese, come si legge in una nota dei "Monumenta Germaniae Historica" (tomo XXXII, dedicato alle cronache di Salimbene de Adam [1221-1287], 1905-1913, p. 93). La testimonianza di Mainardino è relativa proprio a Ravenna tra 1231 e 1232. Mainardino scrive che vide l'imperatore condurre seco "molti animali insueti in Italia: elephanti, dromedarii, cameli, panthere, gerfalchi, leoni, leopardi e falconi bianchi e alochi barbati".
Mainardino è stato definito "uno storico dimenticato del tempo di Federico II" (P. Scheffer-Boichorst, "Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts Diplomatische Forschungen", Berlino, 1897, p. 275). Un'altra citazione da Mainardino, è in un testo di Pandolfo Collenuccio (1444-1504) di Pesaro, "Compendio delle historie del regno di Napoli", Venezia, 1541 (quindi anteriore a Sigonio), p. 80bis: Federico nel novembre 1232 arriva a Ravenna "con grandissima comitiua, e magnificentia, e tra le altre cose menò con sé molti animali insueti in Italia", di cui fa l'elenco che abbiamo appena letto, "e molte altre cose degne di admiratione, e di spettaculo". Nello studio di Scheffer-Boichorst si legge infine (p. 282) che spesso Collenuccio, nell'enumerazione degli animali, coincide con Flavio Biondo.
Flavio Biondo
Ecco che cosa si legge in Flavio Biondo: "Mentre che era Federigo in Vittoria [Sicilia], gli uennero ambasciatori di Aphrica, di Asia, e de lo Egitto; e portarongli a donare Elephanti, Pantere, Dromedarij, Pardi, Orsi bianchi, Leoni, Linci, e Gofi barbati: egli si edificò qui Federigo bellissimi giardini, e serragli; dove teneua bellissime fanciulle; e lascivi garzoni" (Le Historie del Biondo..., Ridotte in Compendio da Papa Pio [II]; e tradotte per Lucio Fauno, Venezia, 1543, p. 172 retro).
Su Mainardino, scrive Augusto Torre (Enciclopedia Dantesca, Roma, 1970): "Vescovo di Imola, della famiglia Aldigeri di Ferrara (dalla quale si pensa derivasse la moglie di Cacciaguida), figlio e fratello di due giudici famosi, fu uno dei più insigni personaggi del suo tempo. Suddiacono e preposito della cattedrale di Ferrara sin dal 1195, il 16 agosto 1207 era già vescovo di Imola. La sua attività si svolse sia nel campo spirituale come in quello temporale, e ne rivelò le spiccate capacità politiche. Fu podestà di Imola (1209-10 e 1221-22), che difese saldamente contro i ripetuti attacchi di Bologna e di Faenza. Per molto tempo lo troviamo vicino a Federico II e ai suoi legati; fu anche vicario imperiale e in questa qualità risolse con grande energia le contese fra Genova e Alba (1226), ma dal 1233 si tenne lontano dalla politica attiva. Il 9 agosto 1249 troviamo già eletto il suo successore; ignoriamo l'anno della sua morte, avvenuta dopo quella data. Scrisse una storia di Imola e una biografia di Federico II, entrambe andate perdute". Nella "Storia dell'Emilia Romagna" (I, 1976, p. 685) Augusto Vasina sottolinea: Mainardinus ebbe una "prepotente vocazione politica filoimperiale".
Nel marzo 1226 da Rimini Federico II ha promulgato la sua Bolla d'oro per confermare la donazione della Prussia all'Ordine Teutonico. La ricorda una lapide (1994) in piazza Cavour, proposta dallo storico Amedeo Montemaggi.
Antonio Montanari
-
Par riministoria le 6 Février 2013 à 17:00
I trentanove ebrei che Ezio Giorgetti ospitò nel suo albergo a Bellaria dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, riuscirono a salvarsi grazie a carte d'identità fornite loro da Virgilio Sacchini (1899-1994).
La vicenda ci è rivelata per la prima volta dalla dottoressa Patrizia Sacchini D'Augusta, nipote di Virgilio. Suo nonno in quei giorni era Commissario Prefettizio del Comune di Savignano sul Rubicone: «Era fascista, ma era anche un uomo buono ed estremamente generoso (con la sua Industria di Legnami e Imballaggi, prima che gli eventi bellici la distruggessero, aveva dato lavoro a tanti Savignanesi ed era un padrone che rispettava profondamente gli operai) ed è per questo che né lui né gli altri membri della sua famiglia furono oggetto di ritorsioni da parte dei partigiani del luogo».
Virgilio Sacchini mise al corrente del suo intervento a favore degli ebrei 'bellariesi' soltanto il proprio figlio Marino.
Ascoltiamo ancora la dottoressa Patrizia Sacchini: «La storia mi è stata raccontata diversi anni fa da mio padre, Marino Sacchini, prendendo spunto da un articolo comparso sul Corriere di Rimini (29/09/1994). Alla fine della guerra mio nonno, Virgilio Sacchini, nato a Savignano sul Rubicone il 26 dicembre 1899, Cavaliere della Corona D’Italia, confidò a mio padre di avere aiutato quel gruppo di ebrei, nel 1943, a fuggire e a raggiungere il Meridione. Si diceva felice che tutto avesse avuto termine, poiché aveva messo a repentaglio, con il suo gesto, la sicurezza della sua famiglia».
Prosegue la dottoressa Sacchini: «Ezio Giorgetti (che, attraverso un amico comune, il Sig.Bertozzi, conosceva mio nonno) ottenne da mio nonno le famose carte d’identità in bianco che nell'articolo pubblicato dal Corriere di Rimini in data 22/01/2007 risulterebbero essere state fornite dal Segretario Comunale di San Mauro Pascoli, Sig. Alfredo Giovanetti. Le carte d’identità appartenevano al Comune di Savignano sul Rubicone e mio nonno, pur correndo un serio pericolo, per il ruolo che ricopriva, non esitò a metterle a disposizione del gruppo di ebrei. Non so se questo fatto fosse noto al Maresciallo Osman Carugno, al Sig. Giovannetti e a Don Emilio Pasolini, immagino che mio nonno avesse chiesto e ottenuto la garanzia del riserbo assoluto attorno al suo gesto. Mi fa immenso piacere offrire questo piccolo contributo alla vostra ricerca. Ricordo mio nonno sempre con tanto affetto e, da convinta antifascista, lo ringrazio di aver contribuito alla salvezza di quel piccolo gruppo di ebrei».
A parlare di carte d'identità fornite ad Ezio Giogetti da Alfredo Giovanetti fu la moglie dello stesso Giorgetti, Lidia Maioli, nel volume curato da Bruno Ghigi nel 1980, «La guerra a Rimini», pag. 321.
["il Ponte", Rimini, n. 5, 03.02.2013]La ricostruzione storica della vicenda bellariese si legge in Riministoria in questi due articoli:
1. Ezio Giorgetti, lo Schindler di Bellaria. Fu aiutato dal vescovo Scozzoli e dal maresciallo Osman Carugno
2. Nazisti, fascisti ed Ebrei a Rimini nella seconda guerra mondiale.
Pubblicato su Corriere Romagna del 29 gennaio 2007.
Antonio Montanari
All'indice di "Rimini 1900" sul "Ponte". Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Storie e storia di Rimini