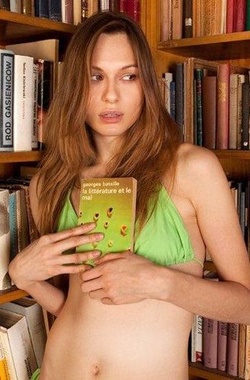-
Cultura e società
-
Par riministoria le 6 Avril 2012 à 18:05
In Toscana si preparavano alle cerimonie ufficiali per il centenario (6 aprile) della morte di Giovanni Pascoli, celebrato in pompa magna a Barga.
Nella Romagna solatìa dolce paese, di Zvanì si ricordavano a bocca storta alcune cose, per etichettarlo come il Vecchio Poeta, e lodare qualcun altro (appena) passato nel mondo dei più.
È successo, per essere precisi, con la scomparsa di Elio Pagliarani, di cui un altro collega poeta (ci si scusi l'iniziale minuscola), Sergio Zavoli, diceva che Pagliarani appunto aveva rifiutato ogni "poetica ridondante, sentimentale e fanciullina".
Poi nella nostra Rimini è arrivato l'assessore provinciale alla Cultura Carlo Bulletti, con un esemplare comunicato da tramandare ai posteri per l'incipit di rara presunzione: "Non tutti sanno che...". E l'assessore, pure lui, se la prendeva con le parole fanciulline, evocandole attraverso richiami precisi come il "linguaggio aulico" e lo "stucchevole lirismo".
Pascoli nel 1897 pubblica un saggio, "Il fanciullino", in cui spiega le sue idee sulla Poesia, mica si mette a cantare canzonette da asilo-nido.
Roberta Cavazzuti in un volume (2004) della collana dedicata alla storia della Letteratura italiana diretta da Ezio Raimondi per la Bruno Mondadori, riassume in maniera mirabile quelle idee.
La novità di Pascoli si può sintetizzare con questa frase della Cavazzuti: "Il poeta coincide con il fanciullo che è in ognuno di noi, non solo in qualche uomo superiore, privilegiato...".
Da non tralasciare un altro passaggio fondamentale: "la poetica pascoliana ripudia" sia la retorica di Carducci sia la dannunziana liturgia della parola.
Bastano queste due brevissime citazioni per comprendere che l'esperienza pascoliana (con tutti gli annessi e connessi storici), è qualcosa di più di un'etichetta di comodo con la quale porla nel dimenticatoio, per privilegiare i meriti di chi è venuto dopo.
Meriti che non mettiamo in discussione, a patto che non li si spedisca in ridicola concorrenza con quelli di chi ha vissuto altre e più lontane epoche.
Zvanì non è un Vecchio Poeta da rinchiudere in soffitta per cedere posto ad altre Glorie più recenti.
Nelle storie della Letteratura, c'è posto per tutti quanti sono scomparsi dal palcoscenico della vita.
Lasciate che a sbranarsi siano i contemporanei vegeti che ambiscono alla pretesa di esserne unici protagonisti. E che, con tutti i mezzi, cercano di realizzare un loro sogno da inutili superuomini.
Antonio Montanari
-
Par riministoria le 11 Novembre 2010 à 16:08
 Esce oggi 11 novembre l'intervista immaginaria di Giulio Giorello a Voltaire, che comincia: "Monsieur le philosophe...".La settimana scorsa Sergio Romano, introducendo il trattato "Sulla tolleranza" dello stesso Voltaire, lo definiva invece "giornalista" ("anche se la parola può sembrare riduttiva") perché "non fu mai un filosofo, nel senso corrente della parola". Anche se, osserva, lo stesso Voltaire si sarebbe definito "philosophe".
Esce oggi 11 novembre l'intervista immaginaria di Giulio Giorello a Voltaire, che comincia: "Monsieur le philosophe...".La settimana scorsa Sergio Romano, introducendo il trattato "Sulla tolleranza" dello stesso Voltaire, lo definiva invece "giornalista" ("anche se la parola può sembrare riduttiva") perché "non fu mai un filosofo, nel senso corrente della parola". Anche se, osserva, lo stesso Voltaire si sarebbe definito "philosophe".
Silvia Ronchey nelle recenti "Vite più che vere di persone illustri" (raccolte sotto il titolo de "Il guscio della tartaruga"), lo chiama "un aristocratico del pensiero" perché così ritiene che lui si considerasse. E lo riassume in questi termini: "François-Marie Arouet fu un avvocato, un libertino, un detenuto, uno speculatore, un viaggiatore, un polemista, un cortigiano, un filosofo, un commediografo, un tragediografo, un narratore. Si chiamò anche Voltaire".
Forse il problema di tutte le biografie sta qui, in quell'essere "anche" quello che poi una persona appare ai posteri.
L'editore di Ronchey spiega alla fine del libro il senso del titolo ("Il guscio della tartaruga"): il guscio è più largo del corpo della tartaruga ed è coperto da un mosaico di scaglie. "Anche queste vite sono un mosaico".
Come (aggiungiamo) forse quelle di tutti noi. Il guaio della Storia è che spesso delle vite ordinarie si perdono le tessere, e nessuno si cura di recuperarle.
Per le esistenze straordinarie, invece, si fa a gara a cercar etichette. Ronchey insegna che è meglio abbondare nell'elenco.
Giorello, che bisogna adottarne una per semplificare le cose, usando l'immagine più semplice e per questo efficace.
Invece Romano cancella tutto il nuovo che la nuova filosofia dei nuovi filosofi del Settecento suggerisce. Il "giornalista Voltaire" agli occhi di Romano ha però una missione politica da compiere, quella di insegnare a contemporanei e posteri il valore della tolleranza, negata dal processo a Jean Calas, accusato d'aver ucciso il figlio per non farlo convertire alla fede cattolica, e poi condannato a morte.
Recente è anche l'edizione del trattato curata da Sergio Luzzato, in cui si racconta come nel 1949 esso divenne un "testo di riferimento" dell'allora Pci, per la traduzione che ne fece Palmiro Togliatti.
Lo storico Luzzato scrive un'intelligente pagina provocatoria che conclude efficacemente: "il paradosso italiano di un Voltaire confiscato dai comunisti", deriva dalla "relativa indifferenza (per non dire l'altezzosa sufficienza) con cui il liberalismo nostrano", tutto "impregnato di umori spiritualisti", aveva guardato "alla materialistica epoca dei Lumi".
-
Par riministoria le 11 Août 2010 à 18:31
Adesso di Liliano Faenza (era nato nel 1922) restano soltanto libri, articoli, saggi, il ricordo di una competenza messa più al servizio della cultura italiana che della città in cui è vissuto, Rimini. E dalla quale non si era mai voluto allontanare. Con quella pigrizia fisica che visse come sfida a se stesso prima che al mondo. Quasi per dimostrare che bastava poco per vivere “bene”. Nei limiti di un concetto di bene che nulla aveva di cattolico, ma semmai era tutto socratico.
Quando parlava di religiosi, il gusto dell'aneddoto graffiante sui vizi segreti di certi ecclesiastici in vista, era l'inevitabile premessa all'elencazione di dati indiscutibili, cioè rispondenti alla verità effettuale delle cose. Aveva un gusto del pettegolezzo come certi scrittori che lo avevano elevato a cornice del ritratto di un personaggio.
Conosceva i classici della letteratura come le sue tasche, non sbagliava i riferimenti, abbondava in citazioni. Non per sfoggio erudito, non per esibizionismo culturale. Soltanto per confermare all'interlocutore che, in fondo, ognuno di noi è una specie di summa dei libri letti. Perché la vita e la Storia insegnano poco, affidate come sono agli egoismi delle persone e agli affari dei gruppi di potere economico e degli apparati politici.
Il suo modo di vivere spartano e vagamente da misantropo, s'accompagnava ad un filantropismo ideologico da socialista ottocentesco, in lotta continua con il trionfante comunismo di mezzo secolo scorso, a cui dedicava derisione e censure.
Per formazione intellettuale avrebbe dovuto sostenere che “la Storia siamo noi”. A rappresentare l'idea poteva bastare un'immagine del “Quarto stato” di Pelizza da Volpedo. Invece finiva per constatare con amarezza e non celato disgusto che “la Storia sono loro”, i potenti di turno che gestivano la cosa pubblica.
Questi potenti si sono sempre disinteressati di lui. Soltanto quando ormai era molto avanti negli anni gli consegnarono un riconoscimento un po' platonico ed un po' patetico, il “Sigismondo d'oro”, più utile agli amministratori cittadini per farsi belli che ai premiati per sentirsi finalmente famosi.
Un ricordo personale del 1961. Mi ero appena diplomato maestro elementare, avevo 19 anni. Partecipai al concorso indetto a Forlì. Mi ritrovai Faenza come vicino di banco. Già allora per noi era un mito. Lui aveva vent'anni più di me. Era laureato, lavorava alle Ferrovie dello Stato. Non aveva nessuna intenzione di cambiare mestiere. Voleva soltanto misurarsi in una prova intellettuale, ammesso che possa essere considerata tale un esame di concorso.
Leggendario era il racconto che si faceva del suo ufficio alle FFSS. Poche carte sul tavolo, inerenti al lavoro. Poi il cassetto della scrivania semiaperto, con i libri da leggere o da citare sui fogli che Faenza andava riempiendo. Agli occhi dei superiori erano carte d'ufficio. Invece si trattava di stesure di articoli, libri, saggi che Liliano Faenza stava componendo, perché poi nel tempo fuori dall'ufficio aveva altro da fare. Passare in libreria, vedere le ultime novità, lanciare qualche divertente frecciata verso questo o quel personaggio pubblico, poi rintanarsi nella biblioteca civica a sfogliare altre carte, a pensare per scrivere altre storie. [24.7.2008]
-
Storie e storia di Rimini