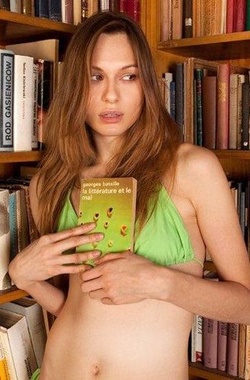-
RiminiLibri
-
Par riministoria le 5 Juin 2015 à 15:54
Anna Rosa Balducci,
«Idee per una mattina di pioggia»Travagli del presente e del passato (ovvero di lontane origini famigliari ebraiche), si fondono in un racconto che offre suggestioni e suggerimenti per comprendere i misteri della Storia e quelli (direbbero i filosofi) della vita.
Il tutto all'insegna di una saggia opinione che leggiamo a p. 73 di «Idee per una mattina di pioggia» di Anna Rosa Balducci (Edizioni Progetto Cultura): «La mente ha bisogno di un recinto largo per non ammalarsi e per non fare ammalare il corpo».
La vita quotidiana è amara in una città governata da «gruppi di potere che di diverso dagli antichi feudatari avevano solo la piccolezza della propria personalità».
Era «un grande paesone fantasma», un «piccolo ghetto di provincia», «con reti di rapporti simili a cosche malavitose».
La penna di Anna Rosa Balducci scava con delicata fermezza, delinea contorni di figure, che lentamente si accrescono nei particolari dei modi e delle idee, suggerendo una conclusione pessimistica che non tocca soltanto il destino della protagonista, Marta, ma «il degrado» di tutto il nostro Paese «negli ultimi venti, forse trenta anni».
L'impresa avviata con alcuni amici, anzi la «piccola avventura da sognatori» è finita.
Dove ricominciare, e come?
Il passato di quegli antenati «sempre un poco spiazzati» rispetto a loro tempi, rivela «quel fremito d'intelligenza» che porta via, lontano, e così salva, mentre sembra sconfiggere. Oppure ci sconfigge, mentre pare che ci salvi?
Perché poi Marta pensa che «forse il mondo delle idee è pura malattia», essendo impossibile raggiungere un giusto equilibrio tra gli opposti nella vita reale quotidiana.
Belle, intense, profonde, le pagine di questo libro di Anna Rosa Balducci, che offre l'esempio di come un'analisi di tipo filosofico possa ancora esprimersi nel racconto, dove ogni storia individuale è collocata in uno sforzo collettivo, generale, insomma storico.Antonio Montanari
(c) RIPRODUZIONE RISERVATA
-
Par riministoria le 2 Mai 2014 à 15:43
A cento anni dalla nascita, Nevio Matteini è ricordato da una biografia che suo figlio Annio Maria ha pubblicato presso Guaraldi.
Il volume raccoglie memorie domestiche, racconta vari panorami storici che hanno fatto da sfondo al lavoro di Nevio Matteini, e documenta un'intensa attività di cronista e di scrittore.
Ho conosciuto bene il prof. Matteini. Mio padre Valfredo curò per l'editore Cappelli di Bologna la diffusione e la vendita di un'opera di Matteini, «Romagna», apparsa nel 1963.
Trent'anni dopo, il 10 gennaio 1993, riprendendo una frase di Sergio Zavoli, secondo cui «Rimini non onora il cittadino che si fa onore», scrivevo quanto segue.
Ci è capitato di parlarne con un vecchio amico che vive e lavora a Milano, l'arch. Annio Maria Matteini, con cui abbiamo amaramente constatato come nulla Rimini faccia per ricordare chi alla nostra città ha dato tanto. Suo padre, lo scrittore Nevio Matteini, è scomparso il 16 gennaio 1992: ad un anno di distanza, la Cultura riminese sembra averlo dimenticato. E con il suo, potremmo citare altri nomi, tra cui quelli del prof. Carlo Alberto Balducci che ci lasciò nell'estate del '91, o di Luigi Pasquini, Davide Minghini, Flavio Lombardini, Oreste Cavallari, morti da più tempo, e quindi testimoni ancora più accusatori dell'andazzo. È crudele che la città del padre di «Amarcord» debba lamentare quell'invecchiamento aterosclerotico che si sostanzia tra le altre cose nella dimenticanza.
Fine della citazione. Ora aggiungo una notizia d'archivio. Rimini non è soltanto la città delle dimenticanza, ma pure dell'arroganza di certi padri inquisitori, di cui fece le spese lo stesso Nevio Matteini, forse per primo, sul finire degli anni Settanta, con un duro attacco ricevuto da un foglio locale, che prendeva di mira la sua Storia di Rimini.
Ho già raccontato anni fa che in seconda Magistrale fui rimandato in Italiano, ed il prof. Matteini disse a mio padre di andare a ripetizione da lui. Alla lettura della prima prova scritta che mi aveva assegnata (i suoi titoli erano chiaramente liceali, ovvero non facili), ebbi la soddisfazione di sentirmi dire: «Ma lei sa scrivere».
La sua abitudine di dare del lei agli studenti. La adottai quando poi cominciai ad insegnare pure io.
Una delle prime supplenze, appena laureato, nella primavera del 1966, fu proprio nella cattedra di Filosofia, tenuta dal prof. Matteini allo Scientifico Serpieri.
Un gruppo di studenti m'interpella per una conversazione pomeridiana autogestita (l'aggettivo non era ancora entrato nel lessico studentesco). Ci vado volentieri, discutiamo a lungo con libertà ed amicizia. Poi alla fine, uno dei ragazzi della mia terza classe mi ferma: «Lei ieri ci ha dato un'interpretazione luterana di sant'Agostino». Mi mostra il quaderno degli appunti. Gli spiego che la frase tra virgolette non era un mio commento ma un testo dello stesso filosofo d'Ippona.
Il giovanotto si giustifica: ha ricevuto l'imbeccata dell'appunto sugli appunti del sottoscritto da un mio collega di corso, l'insegnate di Religione.
Nel libro di Annio Matteini, ci sono pagine di grande onestà intellettuale, come quando egli ricorda quanto suo padre «avesse patito per la propria giovanile adesione al fascismo», senza mai celarla per «differenziarsi dai tanti che avevano cercato di celare o di negare un passato analogo» (p. 19).
Un altro passo da segnalare: il prof. Matteini aveva un assoluto disdegno verso la borghesia arricchita, altolocata ed incolta che pretendeva di dirigere la vita cittadina, anche grazie all'«ostentato ossequio alle gerarchie ecclesiastiche locali».
Antonio MontanariArchivio: Cagliosto narrato da Matteini
-
Par riministoria le 19 Octobre 2012 à 17:55La nuova opera narrativa di Piero Meldini è una specie di romanzo storico, se l'etichetta non suona irriverente: un racconto che prende spunto dalle pagine autobiografiche di una persona esistita davvero, Achille Serpieri. Di esse lo stesso Meldini ed Oriana Maroni avevano curato nel 1989 la pubblicazione, in una felice collana editoriale di Maggioli. Dalla provincia e dal suo mondo un po' soffocante che è al centro del lavoro appena apparso presso Mondadori, Meldini è intellettualmente emigrato dopo i ripetuti successi letterari che gli hanno procurato i quattro romanzi apparsi tra 1994 e 2004.
La pausa di otto anni finisce ora con la nuova opera dal titolo seriamente ambiguo, “Italia. Una storia d'amore”, dove il nome di battesimo della protagonista si confonde con il Paese che vive momenti drammatici alla vigilia dell'ingresso in guerra nel 1915. Il doppio binario del racconto ripercorre le cronache politiche con i giovani a Bologna che protestano in nome di un'Italia che non voleva più parole ma fatti, ovvero cannoni che sparassero contro gli austro-tedeschi e soprattutto mettessero a tacere i neutralisti.
Su questo sfondo, il protagonista del romanzo vive un'avventura d'amore (tranquillizzo i lettori, non ne cito i particolari), all'insegna del più facile discorso sentimentale. Un incontro casuale in treno da Bologna a Rimini, prelude ad una sosta nella nostra città, per raccontarla alla fine di un Ottocento languido che avvolge tutto nella nebbia della memoria.
C'è la malinconia del Kursaal, c'è l'ovvio oppio dei popoli che rende il Tempio malatestiano il monumento dell'amore tra Sigismondo ed Isotta, ci sono le audaci conferenze di Paolo Mantegazza che fanno arrossire la protagonista con imbarazzi che nascono non improvvisi, ma quasi meditati, per un eccesso di verecondia. La quale diventa l'onesto paravento delle finzioni psicologiche e sociali che soltanto alla fine si rivelano tali, quando sappiamo che la bella giovane non è quella che si è raccontata prima in treno e poi nella sosta a Rimini con il compagno di viaggio. Diceva di dover raggiungere un marito geloso, capace di compiere un delitto, se avesse scoperto la tresca con quel passeggero che ha preso il treno a Bologna diretto verso il mare. Ma quel marito è inventato come paravento sociale, ed il lettore scopre la verità soltanto alla fine, e non gliela sveleremo.
Quando Meldini pubblicò “Le avventure galanti di un sovversivo”, ovvero del ricordato Serpieri, ne fece un ritratto efficace, definendolo “generoso, passionale e doppiamente ingenuo”. Oriana Maroni ne scrisse raccontando pure la Rimini di fine Ottocento, con proprietari terrieri e grossi borghesi che avevano preso le redini dei poteri politici ed amministrativi della città, per mantenervi una struttura prevalentemente artigianale nel centro urbano e “la statica realtà mezzadrile della campagna”. Fu una scelta che, in alternativa a quella industriale, aveva il “pregio di portare denaro senza alimentare conflitti di classe”.
Da quei giorni in cui Serpieri colloca la sua vicenda sentimentale con la signora di nome Italia (tra 1868 e 1869), si arriva al loro racconto ideato da Meldini nel contesto inquieto del 1915, quando l'Italia ha una svolta per molti versi drammatica. Dopo il 1918 arriva quel 1922 della marcia su Roma di Mussolini, preannunciata dai toni violenti dei cortei studenteschi nella Bologna dell'aprile 1915.
2004. Il mercante dei destini comprati
[Fonte dell'articolo]
Ambientato nel primo Ottocento, il nuovo romanzo di Piero Meldini, "La falce dell'ultimo quarto" (Mondadori, 186 pp., 16 euro), racconta la storia di Bartolomeo Bartolini che "discendeva da svariate generazioni di commercianti di granaglie. Gli anni di abbondanza li avevano resi ricchi; quelli di carestia ne avevano raddoppiato il patrimonio: perché, piovesse o splendesse il sole, fossero i raccolti magri o abbondanti, erano sempre loro che fissavano i prezzi, loro che intascavano i guadagni". Sullo sfondo c'è una Rimini i cui abitanti hanno uno speciale genio per intrighi e pettegolezzi: litigiosi e "condiscendenti con se stessi ma inflessibili con gli altri", amano godere delle altrui sconfitte più che delle loro vittorie. Il risultato si vede: "Così la città deperiva a vista d'occhio, come un corpo i cui organi siano in guerra fra loro. E come un uomo malato, più peggiorava più si isolava dal mondo circostante". Lo speziale Gioseffo, protagonista secentesco de "L'avvocata delle vertigini" (opera seconda di Meldini, 1996) già aveva detto di Rimini: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Forte del suo denaro, Bartolomeo Bartolini progetta di condizionare il futuro della propria famiglia con la stessa sicurezza con cui opera negli affari. Vedovo e con un figlio che ha tutt'altri interessi, privilegia nel rapporto umano ed aziendale un nipote ex fratre che gli dà grandi soddisfazioni. L'occhio del commerciante di granaglie osserva i loro comportamenti, cerca di indirizzarne la vita secondo i propri piani. Usa come strumento le volontà testamentarie, che muta in continuazione adeguandole agli eventi sorprendenti o dolorosi e tragici che si susseguono nella sua famiglia. Quegli atti notarili che lui fa stendere con inutile preveggenza e consolatorie provvidenze, rappresentano ai suoi occhi la certezza che il destino dovrà avere il corso che lui immagina. Ma le singole esistenze del figlio e del nipote subiscono scarti dalla linea prefissata. Il libero arbitrio delle persone non si fa comperare dal mercante che detta i testamenti con la stessa arroganza con cui può dirigere le compre di grano o stabilirne il prezzo.
Bartolomeo Bartolini è un "uomo tolemaico", una di quelle persone cioè che si considerano al centro dell'universo, come era la terra nell'antico sistema soppiantato dall'eliocentrismo copernicano. E reputa che quanti gli gravitano attorno ricevano da lui luce e calore, ovvero la vita. Ma le pagine dell'esistenza quotidiana di ognuno si girano senza che il ricco mercante possa fermarle. Non gli resta che tentare di resistere al destino, alla Mietitrice che incombe nel dolore e nella malattia, con la speranza sempre più debole, che un filo, un filo soltanto di tutta la matassa esistenziale, gli conceda la possibilità di governare l'altrui destino, le sorti della ditta e della famiglia.
Ma anche quel filo si logora, probabilmente nella meccanica, continua ripetizione d'un fallimento dei suoi progetti. Il romanzo si chiude senza spiegare come e quando si spezzerà l'ultimo sogno. Il lettore può pensare che alla fine, nell'ultimo giorno, a Bartolomeo Bartolini resterà soltanto il ricordo di un'illusione, senza che niente di quanto lui avrebbe voluto e desiderato, possa avverarsi. Il destino degli altri non si compra con il denaro del testamento, non è una partita di granaglie, non è un contratto capestro, non è la forza corruttrice di un'elemosina elargita al clero per avere soddisfazione alle proprie pretese, non è il gioco mondano che permette, a lui ricco, di chiedere per i suoi due eredi la mano di ragazze aristocratiche d'una famiglia in rovina economica.
No, il destino individuale non è in vendita. E Bartolini se n'accorge ogni volta che costringe il notaio a modificare le proprie volontà: "predeterminava le esistenze dei suoi discendenti, e dei loro nati, poneva un'ipoteca sul più lontano futuro". Se n'accorge, ma non lo confessa. Va sempre avanti così, con quell'illusione che lo sorregge nella continua battaglia con la Mietitrice. Con cui dialoga anche nell'ultima pagina: "Aspetta. Che fretta hai?".
Meldini offre in questo quarto romanzo (a dieci anni dal debutto narrativo di successo con "L'avvocata delle vertigini"), un'altra prova di grande maturità artistica che s'esprime anzitutto nello stile con cui costruisce il racconto, poi nella stessa scansione degli eventi che procedono narrando la normalità di vite qualunque, nelle quali si condensano però le ferite simboliche, le angosce nascoste, le speranze tagliate di tutti.
L'abilità dello scrittore dissemina lungo il testo sapienti suggestioni che si offrono al lettore con la discrezione di appunti delicati, senza ostentazioni arroganti. Si veda la scena della nebbia, nella quale il mercante prova "una paura che affondava in ricordi antichi e che riaffiorava di tanto in tanto nei sogni. Era la paura di dissolversi; di disperdesi in una miriade di atomi disertori; di diventare polvere e fumo".
Quegli "atomi disertori" valgono da soli un'emozione che il lettore incassa sollecitando in se stesso un confronto con l'altra pagina in cui a Bartolini sembra di poter veramente raggiungere il suo scopo, combinando il matrimonio del nipote, in una splendida giornata di fine dicembre: "Il cielo era di un fulgido e immacolato color zaffiro, e il sole illuminava tutte le stanze sul davanti della casa, a cominciare dalla sala da pranzo. La luce dorata che entrava dalle finestre, alleata al tepore che spandeva il fuoco del camino annunciava la primavera". Ma quella luce e quel tepore sono un inganno, a conferma che le immagini che scorgiamo non rendono piena testimonianza della verità delle cose, come la figura del santo vescovo Gaudenzio che in piazza della Fontana, "dall'alto del piedistallo, lo guardava arcigno. Il braccio levato sopra la testa e le tre dita aperte non sembravano impartire una benedizione, ma lanciare una scomunica".
1999. Le "lune" dolorose di Meldini
[Fonte dell'articolo]
L'"avvocata delle vertigini" del primo romanzo (1994, Adelphi) non ha mai avuto il dono dell'essere nella carne e tra le cose del mondo, ma Meldini le plasma attorno una biografia che ne fa un personaggio vero, non improbabile e neppure assurdo. Anzi quasi esemplare. L'astuzia narrativa dell'autore introduce leggende che "accennavano, concordi, ad una giovinezza alquanto dissipata", a cui tenne dietro la conversione, dopo un fatto straordinario che muta radicalmente la vita di questa giovane dal nome di Isabetta. Il fatto è un tentativo di suicidio dall'alto di un campanile: ma a salvarla intervengono provvidenzialmente quelle vertigini di cui parla il titolo, e per le quali diventa protettrice di quanti soffrono del male che le impedì il salto nel vuoto.
La storia letteraria dell'"avvocata delle vertigini", è soltanto lo spunto per proiettare il romanzo da questo medioevo (letto e rivissuto attraverso pagine biografiche o documenti), alla nostra realtà contemporanea che s'intravede come sfondo alle scene che inquietano la vita di personaggi dalle esistenze sino ad allora piatte, e turbate all'improvviso proprio dalla presenza di fantasmi di carta che ben presto però diventano minacciosi eventi reali.
Nel secondo romanzo "L'antidoto della malinconia" (1996, Adelphi, Premio Selezione Campiello), Meldini intreccia le parti del suo racconto (ambientato in un cupo scenario di fine Seicento), mescolandovi gli ingredienti più vari. Un amore negato dalla famiglia a Matilde, invaghitasi dell'"uomo sbagliato", per cui viene rinchiusa in monastero. La disperazione di Matilde (figlioccia dello speziale maestro Gioseffo, ed incline "ai pensieri malinconici"), finita pur essa nel suicidio. Il violento "uomo sbagliato" che torna riverito in società, nonostante la macchia di un delitto nato, "nelle fitte nebbie del vino", da una contesa inizialmente intessuta "per gioco". E sullo sfondo Rimini, contro la quale inveisce maestro Gioseffo: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Gioseffo lavorava ad un trattato, da cui Meldini riprende il titolo per il suo romanzo. Lo stratagemma dell'autore moderno di rifarsi all'autore antico, di scrivere un libro su di un libro che non esiste più perché distrutto alla fine dallo stesso Gioseffo ("...cominciò a strappare le pagine a una a una. Il fuoco, onnivoro, le divora con noncurante ingordigia"), permette di realizzare (ancora una volta, come nell'"Avvocata"), una trama leggibile su due piani: in superficie, c'è il racconto delle apparenze (la vita così come ci si mostra), mentre la sottile ma intensa filigrana fa intravedere la "substantia rerum", ed i segreti individuali che si scontrano con quelle stesse apparenze.
La terza prova di Piero Meldini ("Lune", Adelphi, 1999) naviga con grande perizia stilistica in un territorio misterioso ed enigmatico, per dimostrare montalianamente che il calcolo dei dadi mai non torna. E' un racconto fatto in prima persona, nell'angoscioso momento dell'attesa di un intervento chirurgico, con il drammatico rincorrersi di silenzi pungolanti alla meditazione, con l'immagine soave e terribile di un giovane morente, con le infermiere che recano tisane, prelevano sangue. Tutto ha il colore di una paura che spinge il protagonista a spiegarsi in un "grosso quaderno con la copertina nera e i tagli rossi che ricorda un messale".
Sale quasi dall'inconscio l'immagine purificatoria del messale, dove saranno però contenute anche notizie di un carattere tutto sfrenatamente istintivo, che Meldini presenta senza alcun compiacimento, per testimoniare che Andrea Severi, il suo protagonista, vuole stendere un freddo (tuttavia compromettente) verbale a futura memoria, per chiarire a se stesso la serie degli eventi accaduti durante un viaggio in Grecia.
Il libro non si può raccontare, non solo perché la sua conclusione va compresa soltanto dopo averlo letto tutto e non anticipata per gusto di pura cronaca; ma anche perché una volta giunti a quella conclusione, si deve ripassare mentalmente tutta l'opera, cercare di coglierne la struttura ed il valore simbolico dell'indecifrabilità del mondo in cui viviamo, testardamente convinti di essere, tutti noi, registi astuti nell'ideare e costruire ogni passo, ogni momento e situazione.
L'abilità dell'autore sta nel presentarci questa storia complessa con la massima semplicità possibile, con quella 'leggerezza' che può nascere soltanto da un perfetto controllo tecnico e formale della materia. Senza di essa, il racconto avrebbe avuto il carattere non dello straordinario, ma dell'ovvio e del quotidiano; e non avrebbe reso il senso della ricerca del filo per dipanare la matassa delle incongruenze, delle contraddizioni e delle incomprensioni che ci accompagnano.
C'è una frase in cui Meldini riassume il senso del 'castello' entro cui agiscono i suoi personaggi: "Quando, nella rassicurante casualità dei fatti, ci sembra di cogliere una traccia di maligna ostinazione, invochiamo il destino. Qualche volta succede anche a me di pensare che una volontà misteriosa governi gli eventi [...]".
Verso la fine del suo 'verbale', ad Andrea Severi sembra che le parole scritte su quel quaderno si scompongano e ricompongano "per cancellare questa storia". Ma la vita non si cancella. Aspetta di essere raccontata. Sempre.
1996. La malinconia, "epidemia del secolo"
[Fonte dell'articolo]
A due anni dal fortunato esordio con "L'avvocata delle vertigini", Piero Meldini torna in libreria e conferma la sua qualità di felice, originale narratore. Il nuovo libro "L'antidoto della malinconia" (Adelphi, lire 22.000), prosegue il discorso tematico avviato con l'opera prima, di cui ha la stessa natura di racconto filosofico. Rispetto ad essa, presenta però una visione più amara e tragica della realtà umana. Se Isabetta veniva salvata provvidenzialmente dal suicidio, il protagonista di questo secondo romanzo (lo speziale maestro Gioseffo), non ha nessuno che lo trattenga dal mettere in atto il suo disperato progetto.
Nella conclusione della vicenda di maestro Gioseffo, il lettore avverte con commozione la discesa della parabola esistenziale di un personaggio che attraversa le varie scene (della vita e del libro), con una lucida e sofferta meditazione la quale sottolinea, momento dopo momento, ansie, contraddizioni, persecuzioni quotidiane.
Ancora una volta, Meldini intreccia le parti del suo racconto (ambientato in un cupo scenario di fine Seicento), mescolandovi gli ingredienti più vari. Un amore negato dalla famiglia a Matilde, invaghitasi dell'"uomo sbagliato", per cui viene rinchiusa in monastero. La disperazione di Matilde (figlioccia dello speziale, ed incline "ai pensieri malinconici"), finita pur essa nel suicidio. Il violento "uomo sbagliato" che torna riverito in società, nonostante la macchia di un delitto nato, "nelle fitte nebbie del vino", da una contesa inizialmente intessuta "per gioco". E sullo sfondo Rimini, contro la quale inveisce maestro Gioseffo: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Gioseffo lavorava ad un trattato, da cui Meldini riprende il titolo per il suo romanzo. Lo stratagemma dell'autore moderno di rifarsi all'autore antico, di scrivere un libro su di un libro che non esiste più perché distrutto alla fine dallo stesso Gioseffo ("...cominciò a strappare le pagine a una a una. Il fuoco, onnivoro, le divora con noncurante ingordigia"), permette di realizzare (ancora una volta, come nell'Avvocata), una trama leggibile su due piani: in superficie, c'è il racconto delle apparenze (la vita così come ci si mostra), mentre la sottile ma intensa filigrana fa intravedere la substantia rerum, ed i segreti individuali che si scontrano con quelle stesse apparenze.
La dimostrazione di questo procedere (ambiguo non in sé, ma tale soltanto perché rispecchia e riproduce la duplicità dell'esistenza), è proprio nella pagina conclusiva del romanzo di Meldini. Il notaio Bentivegni, cronista della città e fonte preziosa per i futuri "avveduti" lettori, annota "addì 7 novembre 1690" la notizia del ritrovamento del corpo di maestro Gioseffo, e riferisce sul libro da cui egli attendeva la fama: "Il manoscritto non è stato trovato. C'è chi dice che maestro Gioseffo l'abbia distrutto in un moto d'ira. Chi mormora che gli sia stato rubato. I più maligni insinuano che non sia mai esistito se non nella sua immaginazione, fervida quanto alterata. Costoro sostengono che le pagine del libro che lo speziale porse al suo augusto protettore, in accademia, fossero tutte bianche".
Le ultime righe della citazione riferiscono l'avvenimento in cui culmina la vicenda personale di Gioseffo. Accortosi che l'"augusto protettore" (un gelido cardinal Legato), non aveva letto neppur una delle numerose lettere che gli aveva scritto con sofferta elaborazione, Gioseffo gli si ribella proprio nel momento che doveva esser per lui di maggior gloria, sotto gli occhi di tutta la ridicola "accademia dei Pennuti". All'"augusto protettore", egli non porge l'omaggio del libro, ma pronuncia parole che suonano estranee e stonate, in quell'ambiente, come risultava a lui stesso la sua voce: ""Tiranni come la sorte," mormorò "e altrettanto ciechi, i Grandi concedono i loro favori, o li negano, come detta loro il capriccio. [...] Fieri del loro potere, abbagliati dalla loro bellezza, appagati dalla loro perfezione, i Grandi" disse "non vedono e non sentono. [...] Ma che preghiamo o imprechiamo," gemette "che sussurriamo o gridiamo, la nostra è la voce di poveri uomini. Di poveri uomini inascoltati."".
Messo a tacere, tra i rumori di protesta dell'aula, lo speziale fece ritorno a casa, per scrivere l'ultimo capitolo della sua vita, consistente nel cancellare col fuoco il libro in cui aveva cercato di distillare sapientemente l'antidoto alla malinconia, "veleno dei letterati" ed "epidemia del secolo". Dalla fine di quel libro -di Gioseffo-, comincia questo -di Meldini-, cioè inizia il gioco letterario che l'autore moderno argutamente conduce, rendendosi complice ed antagonista al tempo stesso, dello scrittore antico. Dalle ceneri delle pagine di Gioseffo, prendono forma le pagine di questo 'malinconico' romanzo riminese.
1994. "L'avvocata delle vertigini"
[Fonte dell'articolo]
Il romanzo di Piero Meldini ha una struttura composita: si presenta sin dall'inizio come un racconto fitto di misteri, e finisce per essere in sostanza il resoconto probabile dell'unico mistero che attanaglia l'uomo, quello della sua stessa esistenza.
Per rendere questa struttura, l'autore fa ricorso ad una serie di artifizi narrativi, con abbondanza di provocazioni letterarie che attirano il lettore all'interno di una specie di labirinto, ove si mescolano suggestioni eleganti e disperati resoconti di cronaca nera: è una specie di grande gioco delle ombre cinesi, o se si vuole una specie di riproposta del mito platonico della caverna. Le cose che ci stanno di fronte, che cosa rappresentano? Gli accadimenti, anche i più tragici, a che servono, da chi sono voluti? Il fattaccio di sangue, le tracce che spaventano i frettolosi passanti di una città qualsiasi (ma sappiamo, è la nostra città), hanno una loro logica, o sono uno scherzo del destino? O piuttosto non qualcos'altro ancora, che non sveliamo per non togliere al lettore il gusto di scoprire da solo significati, meriti e sostanza di questo romanzo.
La storia parte dal personaggio a cui va l'onore del titolo del libro, quell'"avvocata delle vertigini" che non è mai esistita storicamente. Quando Alberto Cousté ha presentato tempo fa, alla Sala degli Archi, il suo "Sigismondo" edito da Longanesi, un romanzo storico che non teme l'invenzione, ha dovuto rispondere all'osservazione di chi gli faceva notare che a Pesaro non si trova una certa porta di cui parla nel libro. La sua risposta è stata: "Non c'è, ma io l'ho vista".
Anche la nostra "avvocata delle vertigini" non ha mai avuto il dono dell'essere nella carne e tra le cose del mondo, ma Meldini le plasma attorno una biografia che ne fa un personaggio vero, non improbabile e neppure assurdo. Anzi quasi esemplare. L'astuzia narrativa dell'autore introduce leggende che "accennavano, concordi, ad una giovinezza alquanto dissipata", a cui tenne dietro la conversione, dopo un fatto straordinario che muta radicalmente la vita di questa giovane dal nome di Isabetta. Il fatto è un tentativo di suicidio dall'alto di un campanile: ma a salvarla intervengono provvidenzialmente quelle vertigini di cui parla il titolo, e per le quali diventa protettrice di quanti soffrono del male che le impedì il salto nel vuoto.
La storia letteraria dell'"avvocata delle vertigini", è soltanto lo spunto per proiettare il romanzo da questo medioevo (letto e rivissuto attraverso pagine biografiche o documenti), alla nostra realtà contemporanea che s'intravede come sfondo alle scene che inquietano la vita di personaggi dalle esistenze sino ad allora piatte, e turbate all'improvviso proprio dalla presenza di fantasmi di carta che ben presto però diventano minacciosi eventi reali.
Piero Meldini è scrittore e saggista da una vita e lavora come direttore della Biblioteca Civica Gambalunghiana di Rimini. E al centro del romanzo troviamo proprio un bibliotecario, il cui cognome (Manara) riecheggia il nome di quel Manara (Valgimigli) che fu anch'egli bibliotecario ed illustre studioso. Con il personaggio Manara, Meldini all'inizio si è divertito: lo ritrae come colui che spopola la biblioteca Giacomo Antonio Passeri che finisce per non avere più lettori, per poter "trasmettere lo scibile, intonso, a improbabili posteri".
Nell'evolversi del racconto, il paradosso e l'invenzione cedono il passo ad una sofferta riflessione sulla realtà ultima della vita: "Oggi mi sono chiesto, non rida, se Dio esiste [...] E come sarà di là [...]. Perché ogni Sua manifestazione è una minaccia?". E poi ancora: "Affacciato alla finestra, il vescovo riascoltava, tremante, le parole di Agostino: "Cercavo da dove viene il male, e lo cercavo male, e non scorgevo il male della mia ricerca"".
L'impianto e lo svolgimento di quest'opera ne fanno un racconto filosofico: il lettore viene condotto a riflettere su pagine che Meldini ha composto con attenzione e passione. C'è in esse una grande sapienza narrativa che si esprime sia nella costruzione stilistica sia in quella della trama, ove il vivere attuale trova posto come qualcosa di impensabile o strano: il clima del racconto sembra infatti proiettare la vicenda in una situazione antica, invece tutto si svolge ai nostri giorni, a cui sono collegati i tempi fuggiti dell'"avvocata delle vertigini".
Vertigini che ritornano simbolicamente a chiudere le pagine in cui "una furtiva invocazione" ad Isabetta si accompagna al "grido muto al Dio appeso in cucina dell'infanzia fiduciosa, roseo e benedicente". È qui che il vescovo riascolta Agostino, e "a sua immagine e somiglianza, sentì, il Signore Dio suo era infelice".
Archivio Scrittori riminesiAntonio Montanari
-
Par riministoria le 18 Juin 2011 à 11:21
Ci sono ancora studiosi seri che si divertono a scrivere pagine originali, proponendo interrogativi e non soltanto granitiche certezze. Come Giuliana Gardelli che, in "Morte di un monastero e del suo assassino" (Raffaelli) indaga su Scolca con levità di scrittura. Dietro cui si nasconde, senza arroganza alcuna, il suo prestigioso curriculum di studiosa di Storia dell'arte.
Nel 1940 arriva da Roma al Castello Sforzesco di Milano una maiolica di cui si comincia a parlare nel 1972, attribuendola a Carlo Malatesti (1368-1429) di Rimini. Dove si trovava quella maiolica? L'ipotesi avanzata rimanda appunto a Scolca. Del cui monastero si presenta qui la storia, partendo dalla donazione dell'11 gennaio 1418 fatta da Carlo Malatesti per una piccola chiesa, ai frati Agostiniani di San Paolo I Eremita.
A loro nel 1421, subentrano gli Olivetani. I quali iniziano i lavori di ampliamento dell'oratorio. La vicenda del monastero approda all'8 maggio 1802. Quando, dopo le soppressioni napoleoniche degli Ordini religiosi e l'incameramento dei loro beni allo Stato, si decide la sua demolizione.
Dal capitolo dedicato alle riflessioni sulla vicenda, riprendiamo l'inquietante conclusione: "Dove si trovano ora i reperti dell'Abbazia di Scolca? Una ricerca nelle ville sul colle e nelle dimore patrizie del Riminese potrebbe individuarne non dico tutti, ma almeno una parte?". Come è chiaro, alla domanda non possono dare una risposta forte e chiara gli studiosi del ramo, ma altri esperti del patrimonio artistico che, se non siamo male informati, agiscono nell'Arma dei Carabinieri.
Tornando alla Storia ed alle storie di Scolca, non ci allontaniamo dallo spirito di questa domanda avanzata dalla prof. Gardelli, quando apriamo il capitolo successivo. Dove l'autrice torna sulla distruzione di Scolca, ideale e simbolico luogo di un delitto. Infatti i dieci acquirenti di Scolca, sono messi assieme da un avvocato, Domenico Manzoni, che fa una brutta fine. Nato a Faenza nel 1775, a 25 anni è condannato come giacobino ed eretico, per cui si rifugia a Forlì. Alcuni lo qualificano conte, altri lo dicono commerciante di granaglie. Grazie alle quali fa speculazioni bancarie che gli rendono una fortuna enorme, come osservava il compianto storico Antonio Drei. Manzoni è ucciso a Forlì il 26 maggio 1817.
Fu in rapporto con Antonio Canova. A cui nel 1814 ordina una statua che arriva alla famiglia dopo la sua morte. La vedova Geltrude Versari nel 1830 la vende ad un principe russo. Se ne sono perse le tracce. Invece di Canova, a Forlì, si conserva tuttora il monumento sepolcrale per Manzoni donato dallo scultore a Geltrude Versari.
Perché Manzoni fa quella fine? Alcuni studi sulla Romagna prerisorgimentale apparsi fra 1910 e 1918, indicano una certezza: Manzoni cadde vittima di un regolamento di conti interno al mondo della Carboneria. Non si scarta neppure l’ipotesi della rivalità delle Logge massoniche con la Carboneria. Il popolo considerava Manzoni un incettatore di grani, un affamatore in quel tempo di carestia. Sospettato di tradimento dai "cugini" (gli affiliati) carbonari, sarebbe stato punito per il suo agire. Per ottenere privilegi dal governo, scrive Gardelli, avrebbe fatto i nomi dei capi carbonari. Che poi si sarebbero vendicati.
Nel 1824 un delatore confida alla polizia che il ricco banchiere Manzoni è stato ucciso da Vincenzo Rossi e Pietro Lanfranchi. Lanfranchi è pure lui carbonaro, con il grado di "maestro terribile", ovvero di chi mette alla prova i nuovi soci. E pure lui ha fatto una brutta fine a 35 anni nell'agosto 1822, si disse avvelenato in carcere. Lo piansero come prode guerriero che sotto le armi francesi aveva ricoperto il suo corpo di gloriose cicatrici.All'articolo "Le carte segrete di Scolca. Gli Olivetani a Rimini in due antiche storie" [2010].
-
Par riministoria le 23 Juillet 2010 à 18:12
Quindici storie dal lato oscuro, le chiama uno slogan nella quarta di copertina. Sono quelle che Roberto Sapio, magistrato in pensione, napoletano di origine e riminese di adozione, racconta in un libretto interessante per molti aspetti, non ultimo quello di fornirci la testimonianza diretta del suo lavoro, svolto nella "Rimini nera" di cui dice il titolo. Sono storie che partono dagli anni '80 e che dovrebbero delineare, come suggerisce il sottotitolo, "L'altra faccia di una città".
L'introduzione dell'editore Massimo Roccaforte annuncia una Rimini post-moderna come sintesi di quella nuova società italiana in cui tutto sembra perduto, guastato e putrefatto. Il libro di Sapio è come un piccolo mosaico, le cui tessere delineano un'immagine inquietante, se ci si lascia sopraffare dall'emozione. Se usiamo la freddezza che richiede la volontà di capire, scopriamo che non si parla soltanto di Rimini.
Il volume raccoglie testi già apparsi sulla stampa locale e contributi originali, il più importante dei quali, per il suo contenuto e contesto, è quello intitolato "Banditi in divisa", ovvero la storia della banda della "Uno bianca". Storia che meritava maggior spazio, se non tutto il libro, per un approfondimento che appare indispensabile.
Sapio parte dal 18 agosto 1991, quando due senegalesi (Babon Cheka e Malik Ndiay, operai, 27 e 29 anni) sono uccisi a San Mauro Mare: "La Uno bianca degli assassini fugge e, all'altezza di San Vito, non si ferma ad uno stop e quasi investe una Ritmo con a bordo tre ragazzi provenienti da un locale da ballo. Alla rabbiosa protesta di costoro la Uno bianca si mette ad inseguirli sparando un colpo che per fortuna non raggiunge alcuno dei ragazzi, che arrivati al vicino paese, si rifugiarono in un bar mentre gli inseguitori proseguirono verso Torre Pedrera dove abbandonarono la macchina".
Il sostituto procuratore di Rimini Sapio, avvisato dai Carabinieri, interviene sul posto, e decide di saltare le ferie per chiarire il mistero di quel fatto. Si forma una convinzione: quelli che hanno ucciso a San Mauro i due giovani (ferendone un terzo) sono "persone che indossano una divisa o che, all'occorrenza, possono mostrare un tesserino".
Questo è l'aspetto autobiografico del racconto, in cui si aggiunge: la riflessione di quel sostituto procuratore "provocò la reazione dei superiori e la minaccia di esonero dell'inchiesta". A questo punto Sapio riassume come giunse a quella scandalosa conclusione che sarebbe stata confermata dagli sviluppi delle indagini.
Sono considerazioni psicologiche che il cronista può riassumere con una sola parola, arroganza. Sapio fa un ritratto dei banditi basandosi anche sui precedenti episodi in cui la banda della "Uno bianca" ha agito. Quello di San Mauro non è il primo della serie.
Ripercorriamoli, gli altri fatti. Dal libro di Antonella Beccaria intitolato "Uno bianca e trame nere", riprendiamo l'elenco delle vittime con i luoghi dei ferimenti o delle esecuzioni, che precedono il delitto di San Mauro.
Antonio Mosca, poliziotto, ferito a Cesena il 3 ottobre 1987 muore nel 1989; Giampiero Picello, guardia giurata, ucciso il 30 gennaio 1988, Rimini; Carlo Beccari, guardia giurata, ucciso il 19 febbraio 1988, Casalecchio di Reno; Umberto Erriu e Cataldo Stasi, carabinieri, ammazzati il 20 aprile 1988, Castelmaggiore; Adolfino Alessandri, pensionato, ucciso il 26 giugno 1989, Bologna; Primo Zecchi, autista Hera, ammazzato il 6 ottobre 1990, Bologna; Rodolfo Bellinati e Patrizia Della Santina, nomadi, uccisi il 23 dicembre 1990, Bologna; Andrea Farati, benzinaio, e Luigi Pasqui, dirigente aziendale, uccisi il 27 dicembre 1990, Castelmaggiore; Paride Pedini, artigiano, ammazzato il 27 dicembre 1990, Trebbo di Reno; Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, carabinieri, uccisi il 4 gennaio 1991, Bologna; Claudio Bonfiglioli, benzinaio, ammazzato il 20 aprile 1991, Borgo Panigale; Licia Ansaloni, commerciante, e Pietro Capolungo, carabiniere a riposo, ammazzati il 2 maggio 1991, Bologna; Graziano Mirri, benzinaio, ucciso il 19 giugno 1991, Cesena. In tutto fanno 19 vittime. Giancarlo Armorati, pensionato, ferito il 15 gennaio 1990 a Bologna, muore nel 1993. Siamo così a 20 vittime.
Antonio Mosca, ferito a Cesena, era un poliziotto di Rimini. Leggiamo le nostre cronache nel Ponte del 1987. La banda del racket che ha preso di mira l'autosalone riminese di Savino Grossi, è intercettata dalla polizia il 3 ottobre, mentre sta ritirando a Cesena sull'autostrada una valigetta piena di soldi. I banditi sparano contro la vettura di Grossi e l'auto-civetta del Commissariato di Rimini, colpendo tre agenti: Antonio Mosca (39 anni), Luigi Cenci (25), Addolorata Di Campi (22). Il Ponte si domanda: "Dietro tutta la vicenda, c'è solo una richiesta di trenta milioni?". Antonio Mosca muore nel 1989 in seguito a quelle ferite.
Saltiamo al 1988, sabato 31 gennaio. Alla Coop delle Celle, due portavalori sono assaliti da altrettanti malviventi mascherati che sparano tra la folla, con fucili a canne mozze. Una guardia privata, Giampiero Picello, 41 anni, di Ravenna, è uccisa, un suo collega ferito gravemente, altre cinque persone colpite, tra cui una bimba di nove anni raggiunta da pallini alla testa.
È una "nuova malavita senza volto" quella che si affaccia in città, scrive Il Ponte, sottolineando un particolare che sfugge alla cronache dei quotidiani, e che verrà confermato dalla indagini sulla banda riminese della "Uno bianca": "Il piano della fuga era stato predisposto con attenzione, utilizzando scappatoie che solo gente molto pratica della zona" poteva conoscere.
All'allarme che si diffonde in città, il questore di Forlì Francesco D'Onofrio risponde che sulla Riviera la malavita non è un'epidemia come a Palermo, anche se, ammette, la nostra è una zona "estremamente ricettiva ad accogliere una criminalità stanziale". Il vice-questore di Rimini Alessandro Fersini parla di "criminalità che viene da fuori e si muove disposta a portare a termine a qualsiasi prezzo un'impresa".
Le ultime vittime della banda, dopo i due senegalesi, sono Massimiliano Valenti, fattorino, 24 febbraio 1993, Zola Predona; Carlo Poli, elettrauto, 7 ottobre 1993, Riale (BO); Ubaldo Paci, direttore di banca, 24 maggio 1994, Pesaro. Il bilancio finale è di 25 morti e 10 feriti in 103 delitti. Esso non è geograficamente limitato alla nostra zona, per poter parlare soltanto di "Rimini nera".
È la solita storia. Quella delle storie di periferia che scivolano nel dimenticatoio perché le si crede secondarie, in base all'opinione alquanto ridicola che a far notizia dev'essere soltanto quanto accade nelle capitali o nelle grandi città.
Provate a guardare nei libri più famosi sulla recente storia italiana usciti in questi anni: non troverete una riga della vicenda della "Uno bianca". Una agente di Polizia, Simona Mammano, recensendo su Repubblica-Bologna il bel volume di Antonella Beccaria, nel 2007 ha scritto: "Una questione irrisolta per tutte: come è stato possibile che un commando di assassini potesse operare indisturbato per così tanto tempo?", concludendo: "Questa, dunque, è una storia scandita da errori, valutazioni sbagliate, depistaggi palesi e false testimonianze".
Nel 2003, Sandro Provvisionato su "L'Europeo" ha ricordato che il sostituto procuratore di Rimini Roberto Sapio fu "il primo a sostenere (non creduto)" che la banda fosse composta di gente in divisa.
Sapio era osservato da vicino. E minacciato dalla Falange Armata. Anche con un messaggio cifrato, come il richiamo ad un racconto di Poe, "La lettera rubata". Dove una missiva scomparsa nella casa di una gran dama è ritrovata sulla scrivania di un prefetto.
Nel 1995 si è discusso se la banda della "Uno bianca" fosse collegata a Gladio, come suggerivano i servizi segreti francesi. Smentiva Daniele Paci, il magistrato riminese che ha incastrato i sei feroci assassini della banda: "occuparsi dei servizi segreti o della falange, sarebbe come occuparsi dei marziani".
Sulla Falange Armata scrive Beccarla che nel 1994 essa è indicata da una informativa della DIGOS come un gruppo formato da uomini appartenuti al Sisde ed alla Folgore.
Nicola Mancino nel 1991 quale ministro dell'Interno la ritiene composta da "terroristi della disinformazione che lavorano in orario di ufficio".
Un sostituto procuratore romano parla di gente che ha piena disponibilità di una rete informativa all'intero dell'apparato pubblico. Le telefonate intercettate della Falange sono circa 500, delle quali 221 riguardano la banda della "Uno bianca". Tutte arrivano a fattaccio avvenuto.
Nel 1995 a Roma in Senato il prefetto di Forlì Raffaele Pisasale sembra non credere ad un'organizzazione a vasto raggio: "Voglio dire che mi sembra strano che una organizzazione, sia essa terroristica o mafiosa, non sia intervenuta in aiuto, non abbia tentato un qualche intervento".
Quella della "Uno bianca" non è soltanto una vicenda della Rimini nera, ma una pagina sconosciuta e misteriosa delle politica italiana. Come tante altre storie simili. Ridurla ad un fatto locale è una stranezza provinciale di chi, come l'editore, scambia il proprio ombelico per il centro del mondo. Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Storie e storia di Rimini