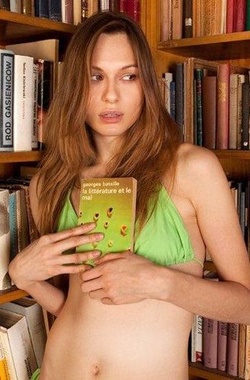-
Par riministoria le 16 Mai 2011 à 12:07
Nelle cronache di quell'anteprima risorgimentale che fu la "rivoluzione del 1831", appare in primo piano anche la figura del vescovo di Rimini dal 1824 al 1833, mons. Ottavio Zollio, patrizio della stessa città, proveniente dalla sede di Pesaro (dove fu nominato nel 1822). "Addottrinatissimo nella Scienza Ecclesiastica" lo definisce don Gaetano Vitali nelle sue "Memorie storiche" di Montefiore Conca (1828). L'avv. concittadino Domenico Missiroli lo chiama "dotto, affabile, misericorde, prudente". Per G. Moroni, autore del "Dizionario di storia ecclesiastica" (1852), fu "lodatissimo pastore".
Nella storia della "Rivoluzione di Romagna del 1831" (Firenze 1851), composta da Antonio Vesi (1805-1855) si legge l'editto diretto il 19 febbraio 1831 dal vescovo Zollio al "dilettissimo suo popolo" per esprimere "il contento da cui è inondato" il suo cuore, "alla vista dell'ordine, della tranquillità e pace" che regnavano in città (p. 14). Richiamato il "dolce precetto lasciatoci per testamento da Gesù Cristo, di amarci scambievolmente come egli ci amò", il vescovo prosegue: "Continuate costantemente, o figli, a battere il sentiero della pace: e voi specialmente, laboriosi cultori dei campi, non date luoghi a sospetti che si mediti strapparvi dai vostri quieti focolari per condurvi violentemente fra lo strepito delle armi".
Il vescovo in questo passo illuminante rimanda a quelle tensioni politiche che poi sfociano in episodi violenti, come segnala G. Bottoni (1914) quando parla di contadini "difensori della religione, nemici dei liberali, ma soprattutto bramosi di denaro". Zollio conclude: "Fidatevi dei magistrati, che con tanto zelo vegliano sulla vostra sicurezza, e riposate sulle provvide cure di quel Dio, che si compiace di chiamarsi il Dio di pace e di amore".
L'editto appare anche ne "Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche" (I, Napoli 1861) di F. A. Gualterio, con un'annotazione relativa al passo diretto ai "laboriosi cultori dei campi": "Con queste parole il vescovo di Rimini smentisce la voce che volevasi dal cardinal Bernetti [prosegretario di Stato] accreditare per muovere il contado".
Come scrive il can. Z. Gambetti (trad. di I. Pascucci), il 5 giugno 1831 a Rimini c'è un "gran tumulto" di liberali al grido di "Morte al Papa, ai Cardinali e Preti". Le manifestazioni proseguono per quel mese: "tutta la città era presa da nuovi timori e da nuove angustie". Il 10 luglio ci scappa un morto tra i liberali. Forse sono due.
-
Par riministoria le 16 Mai 2011 à 12:06
Dopo la fallita "rivoluzione del 1831" e dopo la battaglia delle Celle del 25 marzo, a Rimini, come scriveva il can. Zeffirino Gambetti (trad. di I. Pascucci), il 5 giugno c'è un "gran tumulto" di liberali al grido di "Morte al Papa, ai Cardinali e Preti".
Le manifestazioni proseguono per quel mese: "tutta la città era presa da nuovi timori e da nuove angustie". Il 10 luglio ci scappa un morto tra i liberali.
Il cronista Filippo Giangi (commerciante e maestro di canto, figlio di Nicola che nel 1782 aveva iniziato a raccogliere notizie sui fatti locali) racconta: "quattro ne rimasero feriti lievemente ed uno mortalmente che è un giovane Federici figlio di pescivendolo. Gli altri sono: P. Bagli di Pellegrino, Pagliarani di Fortunato, Patrignani Fabbro ed un altro che è noto".
Il Federici colpito mortalmente, si chiama Cesare e defunge quaranta giorni dopo, il 21 agosto, come troviamo scritto nelle carte del bibliotecario gambalunghiano Antonio Bianchi.
In una pagina Bianchi annota che il 10 luglio restano feriti in tre, "uno de' quali morì 40 giorni dopo".
In altro suo testo si dà per morto (appunto il 21 agosto) il "Federici garzone di pittore ferito mortalmente". Questi sarebbe dunque quel "figlio di pescivendolo" di cui si legge in Giangi.
La descrizione della rivoluzione di Rimini del 1831 è nel cit. testo di Zeffirino Gambetti.
La sua cronaca è importate perché da essa apprendiamo il nome di questo Federici, Cesare.
Alla data del 10 luglio, Gambetti indica il giovane soltanto con il cognome, dicendo che cadde colpito da ferita mortale.
Il 20 agosto registra: "Cesare Federici che il giorno 10 luglio di quest'anno aveva ricevuto una ferita nella sommossa tentata contro Bentivoglio, fu trasportato dall'ospedale a casa sua e il giorno dopo morì".
(I due passi sono nell'ed. a stampa in "Rimini 1831. La battaglia delle Celle", Rimini s. d. ma 1981, pp. 26, 28.)
Nel 1883 David Silvagni pubblica "La corte e la società romana nei secoli XVIII e XIX", dove il morto del 10 luglio si chiama non Cesare ma Giosuè Federici.
Dagli atti ufficiali pubblicati nel 1940, apprendiamo che un Giosuè Federici di Monte Scudo fu arrestato nel 1832 per "canti e beffe contro il papa".
Sui temi qui presentati, si veda in questa pagina speciale:
21. Antefatti dimenticati. Analisi
Rimini prima dell'Unità d'Italia.
Delitti politici, contadini violenti, preti conniventi, un vescovo pacificatore.
-
Par riministoria le 16 Mai 2011 à 12:04
Gli undici delitti politici commessi tra 1847 e 1859 hanno una premessa in fatti avvenuti dopo la fallita "rivoluzione del 1831" e la battaglia delle Celle in cui "pochi ma valorosi italiani" soccombono agli Austriaci, come scrive Girolamo Bottoni in pagine dimenticate (1914). I volontari erano male armati, con poche munizioni, mal vestiti se non addirittura scalzi, "con scarsa o nulla disciplina ed istruzione militare", costretti a misurarsi con "soldati regolari bene armati, bene istruiti e imbaldanziti dai recenti successi" (U. Marcelli).
Per Bottoni le cause della sconfitta del moto "quasi pacifico" sono "l'impotenza direttiva dei capi; l'attaccamento di buona parte dei romagnoli al regime pontificio; la mancanza d'entusiasmo e di fede nella vittoria definitiva". Oltre alla "partecipazione alla ribellione di elementi fedeli al papa, ai liberali, fedelissimi a qualunque governo", come ricava da una lettera inviata al vescovo di Rimini dal can. Macrelli, vicario a Santarcangelo.
I più tenaci nemici dei rivoluzionari sono i contadini, osserva Bottoni. Questi "difensori della religione, nemici dei liberali, ma soprattutto bramosi di denaro", aggrediscono il colonnello Ruffo, ex comandante della guardia nazionale di Rimini. Ruffo si salva pagando loro 50 scudi e ricoverandosi in casa di don Trebbi, arciprete di Spadarolo, "che l'accoglieva amorosamente". Don Trebbi difende Ruffo quando i contadini reclamano "la preda giacobina", con la falsa scusa di una taglia posta sul suo capo. In analoga vicenda un contadino di Ciola dichiara di disporre di 100-200 colleghi "pronti a venire in città per arrestare tutti i giacobini", ovvero i liberali.
Il papista Filippo Giangi (leggiamo in Bottoni) racconta: "L'iniquità di questa classe di gente è divenuta eccessiva e pericolosa sia per il suo istinto di derubare, sia per le false massime che vari loro preti per fini particolari li vanno infondendo sotto l'aspetto religioso, contro ogni principio cristiano e di umanità".
La "barbarie" dei contadini non si limita a depredare dei vestiti "i reduci della resa di Ancona", ma giunge a violare i cadaveri. Sulla spiaggia ad uno dei "fuggiaschi nazionali" uccisi, sono "stati strappati gli occhi", annota Giangi. Scrive Bottoni: "Eppure i piccoli preti erano stati testimoni oculari delle grandi miserie e dei grandi disordini nello stato papale...". Ignora del tutto i fatti chi oggi accredita l'immagine ufficiale di una "pacifica e docile popolazione".
-
Par riministoria le 16 Mai 2011 à 12:02
Nel 1865 ad Ancona appare "Il compito odierno", un testo del dottor Enrico Bilancioni (1808-1888) che denuncia "la pesantezza delle esazioni fiscali e l'altissimo numero di analfabeti esistenti in Italia" (A. Piromalli), 17 milioni sui 22 (77,2%) di cittadini registrati al censimento del 1861.
Gli abitanti dell'Emilia sono 2 milioni (9%), con una media di analfabeti dell'81%, maggiore nelle nostre zone a Sud (A. Berselli).
Pure il padre di Enrico, Domenico Bilancioni, originario di San Clemente, è medico. Lavora come primario all'ospedale di Rimini. Nella carica gli subentra il figlio. Enrico è un fervente sostenitore dell'indipendenza e della libertà della patria. L. Tonini lo descrive "uomo schietto, e di molto ingegno". Alfredo Panzini lo ricorda latinista, filosofo, e morto quasi povero, egli nato ricco.
Nel 1831 Enrico Bilancioni si è prodigato alla Celle nelle cure ai molti feriti tra i duemila volontari scontratisi con l'esercito austriaco il 25 marzo. Lo scontro, per G. C. Mengozzi, salva l'onore della rivoluzione.
Nel 1848, poco dopo l'uccisione (20.9) di un figlio del notaio Giacomo Borghesi, Enrico Bilancioni "fu aggredito da ignoto sicario in mezzo a due suoi teneri figlioletti, mentre con essi conducevasi a casa" (C. Tonini). Quasi difeso dai due fanciulli, Domenico ed Eleonora, egli resta lievemente ferito.
Nello stesso 1848 è nominato nello stato maggiore della Guardia Civica istituita l'anno prima (5.7) da Pio IX, e considerata dai patrioti come una garanzia di libertà. In quel 1847, "anno rivoluzionario per eccellenza", le riforme di Pio IX, come l'editto sulla libertà di stampa (15.3), segnano "una vasta rigenerazione" politica (GCM).
Nel 1859 Enrico Bilancioni è nella Commissione municipale che assume i poteri di Giunta e Consiglio comunale dopo la fine del potere temporale (21.6), contro cui si è sempre battuto in nome della "evangelica legge di libertà e fratellanza". Egli "con animo schietto aveva sempre pubblicamente in libere parole rimproverato l'infausto andazzo del governo romano" (CT). Poi è deputato all'Assemblea della Romagna. Nel 1860 partecipa all'impresa giornalistica della "Favilla" di cui escono soltanto 17 numeri tra 11 febbraio e 14 aprile: è il primo periodico cittadino "in senso assoluto con notizie politiche, economiche e statistiche" (GCM). Lo dirige il medico bolognese Vincenzo Serra (1814-1898) che lavora a Rimini come secondo chirurgo dal 1850, con la collaborazione di un altro medico, Alessandro Niccolini (1825-1892), che il 16 aprile 1859 è stato arrestato per motivi politici. Nel 1880-1881 collabora a "La Parola" rivista rivolta al clero e diretta da don Giovanni Trebbi (P. G. Grassi).
Suo fratello Pietro (1808-1877), vissuto e morto a Ravenna, è avvocato e studioso di letteratura umanistica, compilatore di una "Raccolta di rimatori antichi", apprezzata da Carducci e conservata all'Archiginnasio di Bologna.
Suo figlio Domenico (1841-1884), nato da Laura Marchi, medico e fervente mazziniano è tra i ventotto dirigenti repubblicani arrestati il 2 agosto 1874 a Rimini, sul colle di Covignano, nella villa dell'industriale Ercole Ruffi. Del gruppo faceva parte l'anarchico Domenico Francolini (1850-1926), marito di Costanza Lettimi e legato da fraterna amicizia a Giovanni Pascoli.
-
Par riministoria le 8 Avril 2011 à 16:35
Gioacchino Murat nel 1815 inizia la sua avventura politica. La dichiarazione di guerra è del 15 marzo. Il 30 successivo egli pubblica a Rimini il "Proclama" agli italiani. Con l'armistizio del 20 maggio l'avventura s'interrompe. Murat si rifugia in Corsica e progetta nell'ottobre la riconquista del Regno di Napoli. "Sbarcato presso Pizzo di Calabria con pochi seguaci, fu quasi immediatamente catturato dai borbonici e condannato a morte da una commissione militare. Cadde coraggiosamente colpito da un plotone d'esecuzione il 13 ottobre 1815" (G. Candeloro). Era nato il 25 marzo 1767. Nel 1800 aveva sposato Carolina Bonaparte, sorella minore di Napoleone, nata il 25 marzo 1782.
A Rimini la notizia dell'uccisione di Murat arriva il 24 ottobre. In suo nome l'11 aprile, racconta C. Tonini, alcuni sediziosi avevano percorso le strade della città gridando "Viva l'indipendenza, viva il re Gioacchino, morte ai preti, morte ai papisti". Poi hanno tentato di assalire le case di persone reputate avversari politici, e quelle di quattro sacerdoti. Il notaio e cronista M. A. Zanotti commenta l'esecuzione di Murat: così terminavano miseramente le glorie di quest'uomo che sei mesi prima aveva superbamente cavalcato per la città, alla testa di poderose armate.
Il 27 aprile a Rimini (scrive G. C. Mengozzi) si è verificato "un grave tumulto popolare" di cui fa le spese (con l'arresto) la marchesa Orintia Romagnoli in Sacrati, poetessa cesenate, che era stata grande benefattrice di Aurelio Bertòla, poeta riminese. Gli aveva prestato i soldi necessari all'acquisto di un podere nella Parrocchia di San Lorenzo a Monte. Era il 1794. Due anni dopo Bertòla scappa da Rimini, tentando inutilmente di passare a Firenze e poi a Vienna, dove era stato nel 1778 all'epoca della Nunziatura del riminese Giuseppe Garampi. Si ammala a Bologna. Di qui alla Sacrati chiede che gli procuri "il sussidio" (la piccola pensione universitaria da Pavia): "torno al nido; ma nell'incertezza m'espongo alla mendicità". La miseria lo costringe ad accettare (agosto 1797) il compito di redigere un "giornale patriottico" per i francesi.
Il tumulto del 27 aprile 1815 divide la città in due "fazioni inclini a sostenere anche con la violenza i propri ideali": da un lato ci sono "i fidelini o papalini, forti nella campagna, fra gli artigiani e naturalmente fra le famiglie di più antica nobiltà" (Mengozzi). Molti nobili sono con Murat: lo festeggiano al Casino Civico, attivo sin dal 1803. Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Storie e storia di Rimini