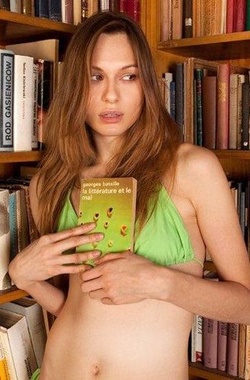-
Nel 1526 si sparge la voce che i Malatesti "pretendevano (ed era vero) di tornare in Rimini", racconta lo storico Cesare Clementini. Non è la prima volta, dopo la sottomissione della città alla Repubblica di Venezia (1503). Nel maggio 1522 Sigismondo II figlio di Pandolfaccio se n'è impadronito, dopo il fallimento del tentativo di pochi mesi prima.
Supplizi atroci
Nel 1523 Rimini è restituita alla Chiesa. Pandolfaccio l'abbandona. Suo figlio Sigismondo II vi rientra nel 1527, e lascia il governo al padre che l'8 aprile 1528 riceve l'investitura da papa Clemente VII (Giulio dei Medici). Nessuno è contento. Sigismondo si lamenta della condotta militare ricevuta dal papa. I cittadini accusano i Malatesti per "la solita tirannica crudeltà" (C. Clementini). A supplizio atroce è sottoposto il papalino Pandolfo Belmonti: fiaccole accendono il lardo porcino cosparso sul corpo, poi appeso ad un palo tra il Castelsismondo e la cattedrale di Santa Colomba. Alla fine Roma manda i suoi soldati. Il 17 giugno 1528 termina il potere malatestiano, con gli ultimi rappresentanti inetti e disgraziati (A. Campana).
A proposito di torture: in un testo dedicato al "Sacco di Roma" (Parigi, 1664), il gonfaloniere fiorentino Luigi Guicciardini annota di "non poter ritenere le lacrime, considerando quanti tormenti, e quanti danni l'huomo solamente dall'huomo riceue", e non dalla fortuna come spesso si dice.
Rancori politici
Nel frattempo Roma ha vissuto i giorni terribili del sacco compiuto dal 6 maggio 1527 sino al febbraio 1528, da 15 mila soldati imperiali, per la maggior parte mercenari tedeschi di fede luterana, scrive Miguel Gotor, definendolo "un episodio clamoroso, destinato a scuotere l'Europa tutta". La fede luterana nel 1525 ha segnato già la tragica repressione dei contadini sollevatisi dal 1524 nella Selva Nera, massacrati ferocemente dal duca di Sassonia.
Nelle storie di Rimini se ne parla poco. Luigi Tonini considera il sacco come una delle tumultuose vicende delle quali i Malatesti profittano per riaffacciarsi a Rimini. Più attento il suo maestro Antonio Bianchi, che rimanda al parere di "alcuni storici" che lo definiscono frutto della politica ambigua del papa che faceva paci o guerre "secondo la speranza d'ingrandire lo Stato proprio e quello de' parenti".
Il sacco turba la vita della capitale del mondo cattolico, con ripercussioni inevitabili sulla periferia. "La percezione generale fu quella di una frattura epocale, che giungeva a sconvolgere il corso della storia", scrive G. Corabi: Roma "tornava ad essere la Babilonia punita dalla profezia giovannea", con implicazioni che riguardavano la storia dell'intera Chiesa, mentre le truppe si abbandonano "a gesti di dissacrazione e profanazione", con un rancore di stampo politico che era diffuso pure in ambienti non protestanti.
La rovina d'Italia
Per Francesco Guicciardini, dalla calata di Carlo VIII (1494) al sacco di Roma si consuma "la ruina d'Italia". Il quadro europeo ha visto nel 1525 la cattura e la deportazione in Spagna di Francesco I di Francia, e l'anno dopo un attacco dell'imperatore Carlo V contro Clemente VII. Il quale, scrisse Francesco Vettori, fu eletto "senza simonia" e visse sempre religiosamente e prudente quanto nessun altro uomo.
Si legge in Cesare Cantù (1865): "la Germania si vendicava della superiorità intellettuale e morale dell'Italia". La barbarie superba metteva sotto i piedi la civiltà che la mortificava. I lanzichenecchi, istituiti nel 1493, sono soldati mercenari di professione, autorizzati a saccheggiare il luogo dove si trovano se non arriva regolare la paga ogni cinque giorni. È il caso di Roma nel 1527: essi sono rimasti senza soldi dopo la morte del loro generale Giorgio Fronspergh.
Una relazione diplomatica del 17 marzo, inviata a Roma ma pure ad altri Stati, faceva sperare che con la scomparsa del condottiero "questa gente s'avesse a dissolvere". Invece gli invasori restano a Roma per nove mesi. Li dimezza in numero la peste. Che colpisce anche la popolazione locale, già con più di 10 mila vittime provocate da quei soldati. Furono 6 mila soltanto il primo giorno, secondo la testimonianza di un lanzichenecco.
Nelle case di tutti
Il cardinale vescovo di Como Scaramuccia Trivulzio, insigne giureconsulto milanese con cattedra all'Università di Pavia, assiste ai saccheggi delle case non solo di prelati e mercanti, ma persino dei poveri acquaroli. Ai cardinali, i lanzichenecchi impongono robusti riscatti per lasciar tranquilli i loro palazzi. Ricevuti i soldi, non tengono fede alla parola data. Al cardinal Giovanni Piccolomini è riservata una cattura oltraggiosa, con calci e pugni. A suo fratello chiedono un riscatto che non serve a nulla, perché lo legano in una stalla minacciando di mozzargli il capo se la somma non sarà raddoppiata. Ricevono una cambiale. Tutte le case dei cardinali sono ripulite, e si oltraggiano le donne che vi si trovano.
Leggiamo ancora il cardinale Trivulzio, da una lettera al suo segretario Jacopo Baratero: "Tutti li monasteri e chiese tanto di frati quanto di monache santissimi saccheggiati; bastonate molte monache vecchie; violate e rubate molte monache giovane e fatte prisione; tolti tutti li paramenti, calici; levati gli argenti dalle chiese; tolti tutti li tabernaculi dove era il corpus Domini, e gettata l'ostia sacrata ora in terra ora in foco, ora messa sotto li piedi, ora in la padella a rostirla, ora romperla in cento pezzi; tutte le reliquie spogliate delli argenti che erono attorno, e gettato le reliquie dove li è parso". Un diplomatico veneto scrive che l'inferno è nulla in confronto alla vista che Roma presenta.
Belve fameliche
Il barone Camillo Trasmondo-Frangipani dei duchi di Mirabello, nel 1866 pubblicando a Ginevra una "Relazione" sul sacco di Roma scritta dal barone di Mirabello Giovanni Antonio Trasmondo (intimo di papa Clemente VII), parla di "accozzate orde di venturieri" che assunsero abusivamente il nome di esercito perché erano disordinate e prive di disciplina militare, agendo quali belve fameliche. La "Relazione" ed altri testi che l'accompagnano, sottolineano il contesto politico internazionale in cui avviene il sacco. Si parla pure delle terre di Romagna, dove ogni giorno si facevano "novità per causa di partialità", in una lettera (1531) di Mercurino Catinara, fratello del cancelliere di Spagna e commissario dell'esercito imperiale di Carlo V.
Quadro desolante
André Chastel, sulla scia di Guicciardini e Burckhardt, vede nel sacco di Roma non soltanto un evento traumatico per tutta la penisola, ma una frattura che spezza in due la vita oltre che della città del papa, pure della penisola.
In Romagna il panorama è altrettanto triste, e non per colpa di un sacco imposto da truppe straniere. Augusto Vasina registra "accanto all'abbandono delle campagne, la devastazione talora rinnovata delle nostre città per lotte intestine, saccheggi di mercenari o distruzioni per rappresaglia". È il quadro "desolante di dissesti materiali e sociali, di fronte ai quali impallidisce ogni tradizione nobiliare, ogni memoria di vita cortigiana, per quanto splendide possano essere state". Le masse s'impoveriscono, la finanza locale va in dissesto. Si perde il senso civico. I ceti borghesi hanno un comportamento ambiguo, smarrendo il compito della loro funzione mediatrice fra i nobili e gli strati più umili della società.
Per il sacco, Roma vive una fase di bassa congiuntura, scrive V. De Caprio: è chiuso lo "Studium Urbis", e crolla il mito umanistico della città. Nel 1528 Rimini, passata dal 1523 alla Santa Sede, vede assaltati dalla plebe l'archivio pubblico e la cancelleria posti nel convento di San Francesco. Nel 1529 Carlo V batte le truppe di papa e Francia. L'anno dopo è incoronato a Bologna.
(3. Continua)
A "Rimini moderna" 1
A "Rimini moderna" 2
All'indice di "Rimini moderna"
-
IIl più importante dei personaggi malatestiani nelle vicende italiani ed internazionali di XIV e XV sec. prima di Sigismondo, è suo zio Carlo (1368-1429). La vicenda politica di Carlo è strettamente legata a quella della Chiesa. Papa Gregorio XII, eletto nel 1405, si rifugia a Rimini il 3 novembre 1408 mentre si prepara il concilio di Pisa e dopo che Carlo lo ha salvato da un tentativo di cattura.
Da Praga a Londra
La grande stagione malatestiana all'interno della vita della Chiesa comincia in questa occasione. Anche se ha precedenti talora dimenticati nel secolo precedente, quando nel 1357 Pandolfo II è a Praga ed a Londra in veste d'inviato pontificio. Come un'ombra lo controlla il nobile francese Sagremor de Pommier che lavora a Milano da agente diplomatico e fidato corriere dei Visconti, quando Pandolfo è al loro servizio quale comandante delle truppe. Sagremor prima pensa di passare al servizio dell'impero, poi cambia idea, infine si farà monaco. A Praga il Malatesti è stato preceduto dallo stesso Sagremor che accompagnava Francesco Petrarca. Sagremor raggiunge Pandolfo a Praga per tornare a Milano a denunciarlo come spia antiviscontea. Di nuovo a Praga, Sagremor non trova più Pandolfo direttosi a Londra. Qui Sagremor lo raggiunge per dargli una lezione: lo sfida a duello. Pandolfo fa finta di nulla e Sagremor va a lamentarsi con il re Edoardo III. Il quale mette per iscritto quello che Sagremor gli ha riferito, per difendere l'onore del messo francese dei Visconti e denigrare l'italiano Malatesti.
Nuovo assetto politico
La missione europea di Pandolfo II appare come parte di un progetto ecclesiastico che doveva tener d'occhio il contesto continentale, e che culmina nello stesso 1357 con le "Costituzioni" promulgate da Albornoz per sistemare una volta per tutte le questioni politiche nelle terre dello Stato della Chiesa, con uno stabile ordinamento giuridico ed amministrativo.
Sull'azione politica di Albornoz restano fondamentali le pagine di Gina Fasoli. Alternando trattative diplomatiche a vigorose azioni militari, Albornoz crea "un sistema di poteri locali abbastanza forti per non essere sopraffatti dai vicini, ma non tanto forti da potersi unire e formare fra di loro un blocco" mirante ad ostacolare la sovranità papale. Le "Costituzioni" da lui emanate (e chiamate egidiane dal suo nome di battesimo), riprendono vecchie leggi, corrette ed adattate alle nuove esigenze. Si fornisce così "un testo che costituiva il diritto generale cui le leggi locali e particolari dovevano conformarsi".
Storie di nozze
Carlo, per contattare il collegio cardinalizio, utilizza Malatesta I (1366-1429), signore di Pesaro, che in precedenza si è offerto a Gregorio XII per una missione diplomatica presso il re di Francia, inseritosi nelle dispute ecclesiastiche per interessi personali.
La parentela fra il ramo marchigiano e quello riminese, è in apparenza lontana. Il capostipite è Pandolfo I (1304-1326) figlio del fondatore della dinastia Malatesta da Verucchio che aveva conquistato Rimini nel 1295. Con Pandolfo I, il rettore della Marca anconitana Amelio di Lautrec, firma un trattato per contrastare i ghibellini ed i ribelli. Pandolfo I, come ringraziamento per la "lotta onorevolmente sostenuta" al servizio della Chiesa, riceve un dono particolare. Amelio concede in sposa (1324) la propria nipote Elisa, figlia di Guglielmo signore della Valletta, al figlio di Pandolfo, Galeotto I detto "l'ardito". Elisa genera Rengarda e muore nel 1366.
Cleofe bizantina
Da Pandolfo I nasce, oltre a Galeotto I (1299-1385), anche Malatesta Antico detto Guastafamiglie (1322-1364) al quale fa capo il ramo marchigiano con suo figlio Pandolfo II (1315 c.-1373) signore di Pesaro, Fano e Fossombrone, ed il figlio di costui Malatesta I, padre di Cleofe e Galeazzo.
Il 19 gennaio 1421 Cleofe sposa Teodoro Paleologo (1396-1448), despota di Morea e figlio dell'imperatore bizantino Manuele II (1350-1425). Di questo matrimonio, concluso nel 1433 con la morte forse violenta di Cleofe, i contemporanei non hanno scritto la cronaca. Ed i posteri ne hanno a lungo travisata la storia, sino agli studi di Silvia Ronchey (2006). Sul finire del 1427 o all'inizio del 1428 nasce la loro figlia Elena Paleologa, la prima erede diretta al trono di Costantinopoli oltre che di Mistra, perché i fratelli di suo padre non hanno e non avrebbero avuto figli. Nel 1442 sposa Giovanni III di Lusignano (1418-1458), re di Cipro (1432-1458), e muore l'11 aprile 1458. La loro primogenita Carlotta (1442-1487) va a nozze dapprima (1456) con Giovanni di Portogallo (1433-1457) e poi (1459) con Luigi di Savoia conte di Genova (1436-1482).
Il ramo riminese
Il ramo riminese-romagnolo deriva da Galeotto I, fratello del bisnonno di Cleofe e Galeazzo. Carlo è figlio di Galeotto I. A consolidare la parentela, oltre gli affari e le imprese mercenarie, sono state due sorelle di Camerino, Gentile da Varano sposatasi con Galeotto I (1367), ed Elisabetta con Malatesta I (1383).
Malatesta I è stato in affari con Urbano VI, prestandogli diecimila fiorini e ricevendo in pegno biennale il vicariato nella città di Orte (1387). Il papa gli ha anche chiesto il suo aiuto nello stesso anno per proteggere l'arcivescovo di Ravenna Cosimo Migliorati, cacciato dalla città. E poi nel 1391, di difendere gli interessi della Santa Sede contro i ribelli di Ostra (Montalboddo).
I lavori a Pisa iniziano il 25 marzo 1409. Gregorio XII è dichiarato deposto. Carlo arriva a Pisa come mediatore fra Gregorio XII ed i padri conciliari, ma in sostanza quale suo difensore. Non è accettata la sua offerta di Rimini per sede dell'assise ecclesiastica, parendogli Pisa non adatta in quanto sottoposta alla dominazione dei fiorentini, avversari di Gregorio XII. Il primo approccio fra Carlo ed il concilio avviene attraverso Malatesta I che si era attivato dopo l'elezione di Gregorio XII, avvenuta il 2 dicembre 1406, ricevendo in premio nel 1410 un cospicuo vitalizio.
Tutto cambia
Sul finire del 1400 e nei primi anni del 1500, tutto cambia in Italia. C'è la rapida discesa di Carlo VIII re di Francia (1494), che scuote la debole politica dei nostri Stati, dimostrandone la crisi e la fragilità militare. La Lega antifrancese che poi si forma ha effetti contrari a quelli sperati: è l'apertura della penisola alle altrui mire espansionistiche, come scrive Miguel Gotor. Luigi XII guarda a Milano, espugnandola nel 1499.
Prima della calata di Francesco I (1515), c'è l'avventura di Cesare Borgia, che Tommaso Tommasi (1608-1658) descrive: “Ottenne al suo primo arrivo senza alcun contrasto la Città di Pesaro, poiché Giovanni Sforza che n'era Signor [...] lasciò, ch'ei fosse ammesso prontamente al possesso della Città. Seguì l'essempio di lui Pandolfo Malatesta Signor di Rimini; onde impadronitosi il medesimo Duca anche di quella Città, e lasciativi i necessarii presidii, se ne passò senza dimora alla espugnatione di Faenza...”.
Pandolfo tenta di recuperare Rimini, ma incontra dura resistenza, “non godendo la medesima benevolenza del popolo, che gli altri” Signori di Romagna. Poi anche Rimini cade in mano alla Repubblica Veneta, “havendo assegnata in ricompensa a Pandolfo, e suoi discendenti colla nobiltà Veneta la terra di Citadella nel territorio di Padoua, e perpetua condotta di gente d'armi”.
La Romagna per Niccolò Machiavelli “era tutta piena di latrocinii, di brighe e di ogni altra ragione di insolenzia”. Per ridurla pacifica e obbediente, Borgia usa il “buon governo” di Ramirro de Lorqua. Che però si mostra uomo crudele e risoluto per cui è fatto decapitare da Borgia, a Cesena sulla piazza la sera di Natale, con un coltellaccio da macellaio, come racconta il cronista Giuliano Fantaguzzi. E tutti rimasero soddisfatti e stupiti, conclude Machiavelli.
(2. Continua, "il Ponte", Rimini, 11.11.2012)
A "Rimini moderna" 1
All'indice di "Rimini moderna"
Antonio Montanari
-
Tentiamo di raccontare per temi le vicende storiche di Rimini moderna, tra fine 1400 ed inizio 1800. Passeremo poi alla Rimini contemporanea sino al principio del 2000. Rimini moderna nasce dalle ceneri del potere dei Malatesti, sfaldatosi lentamente, non per l'inettitudine dei protagonisti di quella famiglia, ma per una complessa serie di contrasti sociali, politici ed economici che, qui come altrove, mettono in moto ribellioni, alleanze, tradimenti.
Una crisi politica
Il più grande di tutti i Malatesti, Sigismondo Pandolfo, sperimenta tutto ciò sin dal momento in cui nel 1429 a 12 anni succede allo zio Carlo, assieme ai fratelli Galeotto Roberto (18) e Domenico Malatesta Novello (11), come lui figli naturali di Pandolfo III signore di Brescia. Essi governano Cesena, Rimini e Fano, sino alla scomparsa dello stesso Galeotto Roberto (10 ottobre 1432), assistiti dalla vedova di Carlo, Elisabetta Gonzaga. Contro di loro gli aristocratici creano quella che la storica Anna Falcioni chiama una pericolosa opposizione interna. Un altro Malatesti, Giovanni di Ramberto discendente da Gianciotto fallisce (maggio 1431) nel tentare un colpo di Stato, ma getta Rimini nel caos, mentre Venezia invia da Cesenatico verso Rimini alcune galere.
Lo storico Cesare Clementini (1627) ricorda che oltre agli aristocratici si muove pure quella plebe “che facilmente inchina al male”. C'è penuria di viveri. Il popolino se la prende con i macellai e le case ed i banchi degli Ebrei, accusandoli di non rispettare la domenica. Altri Ebrei aiutano i Malatesti a pagare i grossi debiti lasciati da Carlo con Roma: essi vivono a Rimini, Cesena e Fano, scrive Francesco Gaetano Battaglini (1794). Come grazioso ringraziamento, Galeotto Roberto (1432) ottiene da papa Eugenio IV (Gabriele Condulmer) di obbligarli a portare il “segno”. Secondo Battaglini, Galeotto Roberto non poteva “tollerare, che gli Ebrei già in grande numero stanziati nel suo dominio, vantando non so quale indulto impetrato da Papa Martino, vivessero e praticassero confusi tra i Cristiani senza distinzione”.
Contro gli Ebrei
I Malatesti, costretti ad affrontare una rivolta popolare causata dalla mancanza di viveri, per portare la pace sociale nel loro dominio ricorrono a questo provvedimento fortemente in contraddizione con la realtà politica in cui vivevano. Sulla stessa strada della lotta agli Ebrei Rimini si ritrova poi nel 1489, quando per loro decide un'imposta destinata a finanziare la difesa costiera contro i Turchi; nel 1503 con un nuovo assalto ai loro banchi; e nel 1515 con la proposta di bandirli dalla città quali nemici della Religione e promotori di scandali nel popolo, dopo aver loro imposto d'indossare una berretta gialla se maschi ed una benda anch'essa gialla se donne.
Il 22 giugno 1510 gli è stata però concessa l'autorizzazione a “facere bancum imprestitorum”, cioè di svolgere legalmente attività finanziaria. È un segno preciso della crisi economica locale. Come ricompensa al loro aiuto, nel 1548 Rimini gli istituisce il ghetto, anticipando la “bolla” di Paolo IV del 1555.
Campagne inquiete
Il grande secolo dell'Umanesimo malatestiano si chiude nel 1498 con una sommossa aristocratica nella chiesa di Sant'Agostino, che mira a cacciare Pandolfaccio, salvato dalla plebe. I capi della congiura sono giustiziati. I loro cadaveri, appesi ai merli della rocca di Sigismondo.
Il 10 ottobre 1500 Pandolfaccio se ne va da Rimini, passata in potere al duca Valentino, Cesare Borgia. Le campagne riminesi sono inquiete, come testimoniano servizi segreti ed esponenti politici della Serenissima. Nell'autunno del 1502 e nell'estate del 1503 si registrano sollevazioni di villani a favore di Pandolfo, con distruzioni di libri e altro, come nei suoi “Diarii” scrive il diplomatico veneziano Marin Sanudo il Giovane.
Nel 1503 dal 2 ottobre al 24 novembre, Pandolfo è di nuovo signore di Rimini, ma sotto il governo veneziano: “la misera città rimase alla discrezione dei furibondi vincitori” che saccheggiarono dovunque e se la presero anche con gli Ebrei ed i loro banchi (L. Tonini). C'è uno spargimento di sangue in cui restano uccisi pure molti popolani. Il 16 dicembre Pandolfaccio cede la città alla Serenissima.
Cronache di delitti
Dopo la morte di Sigismondo (1468) Rimini è governata dalla vedova Isotta e dai figli Sallustio, avuto dalla bolognese Gentile de Ramexinis, e Roberto, nato dalla fanese Vannetta de Toschi. Essi pubblicano un illuminato bando che concede la libertà di commercio d'importazione a tutti i mercanti cittadini e forestieri. L'ordine pubblico è agitato da una serie di delitti eccellenti. Nello stesso 1468 è ucciso Nicola Agolanti. Si sospetta un fatto passionale, accusando Roberto Malatesti, amante della vedova Elisabetta degli Atti che lo scagiona. Da Roberto lei ha avuto un figlio, Troilo. Elisabetta (figlia di Antonio fratello di Isotta moglie di Sigismondo), sposa in seconde nozze il futuro capo dei cospiratori del 1498, Adimario Adimari.
Nel 1470 tocca a Sallustio, trafitto da una spada. Il colpevole è individuato in Giovanni Marcheselli, linciato dalla folla. Giovanni Marcheselli è accusato dalla moglie Simona di Barignano il cui padre Giovanni è fratello di Antonia, la madre di Sigismondo Pandolfo Malatesti. Una sorella di Giovanni Marcheselli, Lena, è la seconda moglie di Giovanni di Barignano, il padre di Simona.
Malatesti rifiutati
C'è un continuo rincorrersi e rinchiudersi in una specie di cerchio politico che rappresenta la proiezione psicologica delle mura di una città o di un castello. Mura che non servono a nulla se non a delimitare (e ad esasperare) continue esplosioni di odio. Questo giro ristretto aggrava situazioni che non hanno sbocchi, come dimostra la storia di Sallustio.
Egli s'invaghisce di una giovane di casa Marcheselli. La sua pretesa di avere l'amore che desidera, è respinta nel più classico modo di quanti, abituati alla guerra, non sanno ragionare che con il pugnale. Giovanni Marcheselli uccide Sallustio. La moglie di Giovanni, Simona di Barignano, lo accusa apertamente: confessa come Sallustio “fu morto” in casa sua, si legge in una lettera di Malatesta da Fano a Ludovico II Gonzaga. Resta il sospetto che non si sia trattato di un fatto politico vero e proprio, ma di una specie di delitto d'onore: non si voleva far entrare un Malatesti nella famiglia Marcheselli.
Nel 1492 durante una festa in maschera, Raimondo Malatesti, discendente di un ramo collaterale, è ucciso dai figli di suo fratello Galeotto Lodovico, in casa di Elisabetta, madre di Pandolfaccio.
Si muore di fame
L'uccisione di Raimondo è considerata da Cesare Clementini all'origine di tutti i mali che poi affliggono Rimini, ovvero “il precipizio de' cittadini e l'esterminio de signori” Malatesti. Dei quali Raimondo era stato uomo di fiducia in momenti difficili. Morto Roberto signore di Rimini (1482), gli è subentrato il figlio Pandolfaccio (di sette anni), per cui in suo nome guidano gli affari della città Raimondo ed il proprio fratello Galeotto Lodovico. Il quale contro Pandolfaccio nel 1492 tenta una congiura, mandata all'aria dalla sua seconda moglie Violante Aldobrandini, sorella di Elisabetta, madre di Pandolfaccio stesso.
Nel marzo 1497 “a Rimano morivano di fame”, ricorda Martin Sanudo, citando gli aiuti inviati in città dal suo governo, e la visita fatta in laguna da Pandolfaccio e sua madre Elisabetta Aldobrandini, sorella del «conte Zoan» da Ravenna, condottiero della Serenissima.
Nell'agosto 1497 scompare Elisabetta Aldobrandini. Suo figlio Pandolfaccio governa in preda ad uno spirito di vendetta, osserva L. Tonini. Il 20 gennaio 1498 gli aristocratici tentano in Sant'Agostino la sommossa già ricordata, con la plebe che corre a salvare il Malatesti.
(1. Continua, "il Ponte", Rimini, 28.10.2012)
A "Rimini moderna" 2
All'indice di "Rimini moderna"
Antonio Montanari
-
La nuova opera narrativa di Piero Meldini è una specie di romanzo storico, se l'etichetta non suona irriverente: un racconto che prende spunto dalle pagine autobiografiche di una persona esistita davvero, Achille Serpieri. Di esse lo stesso Meldini ed Oriana Maroni avevano curato nel 1989 la pubblicazione, in una felice collana editoriale di Maggioli. Dalla provincia e dal suo mondo un po' soffocante che è al centro del lavoro appena apparso presso Mondadori, Meldini è intellettualmente emigrato dopo i ripetuti successi letterari che gli hanno procurato i quattro romanzi apparsi tra 1994 e 2004.
La pausa di otto anni finisce ora con la nuova opera dal titolo seriamente ambiguo, “Italia. Una storia d'amore”, dove il nome di battesimo della protagonista si confonde con il Paese che vive momenti drammatici alla vigilia dell'ingresso in guerra nel 1915. Il doppio binario del racconto ripercorre le cronache politiche con i giovani a Bologna che protestano in nome di un'Italia che non voleva più parole ma fatti, ovvero cannoni che sparassero contro gli austro-tedeschi e soprattutto mettessero a tacere i neutralisti.
Su questo sfondo, il protagonista del romanzo vive un'avventura d'amore (tranquillizzo i lettori, non ne cito i particolari), all'insegna del più facile discorso sentimentale. Un incontro casuale in treno da Bologna a Rimini, prelude ad una sosta nella nostra città, per raccontarla alla fine di un Ottocento languido che avvolge tutto nella nebbia della memoria.
C'è la malinconia del Kursaal, c'è l'ovvio oppio dei popoli che rende il Tempio malatestiano il monumento dell'amore tra Sigismondo ed Isotta, ci sono le audaci conferenze di Paolo Mantegazza che fanno arrossire la protagonista con imbarazzi che nascono non improvvisi, ma quasi meditati, per un eccesso di verecondia. La quale diventa l'onesto paravento delle finzioni psicologiche e sociali che soltanto alla fine si rivelano tali, quando sappiamo che la bella giovane non è quella che si è raccontata prima in treno e poi nella sosta a Rimini con il compagno di viaggio. Diceva di dover raggiungere un marito geloso, capace di compiere un delitto, se avesse scoperto la tresca con quel passeggero che ha preso il treno a Bologna diretto verso il mare. Ma quel marito è inventato come paravento sociale, ed il lettore scopre la verità soltanto alla fine, e non gliela sveleremo.
Quando Meldini pubblicò “Le avventure galanti di un sovversivo”, ovvero del ricordato Serpieri, ne fece un ritratto efficace, definendolo “generoso, passionale e doppiamente ingenuo”. Oriana Maroni ne scrisse raccontando pure la Rimini di fine Ottocento, con proprietari terrieri e grossi borghesi che avevano preso le redini dei poteri politici ed amministrativi della città, per mantenervi una struttura prevalentemente artigianale nel centro urbano e “la statica realtà mezzadrile della campagna”. Fu una scelta che, in alternativa a quella industriale, aveva il “pregio di portare denaro senza alimentare conflitti di classe”.
Da quei giorni in cui Serpieri colloca la sua vicenda sentimentale con la signora di nome Italia (tra 1868 e 1869), si arriva al loro racconto ideato da Meldini nel contesto inquieto del 1915, quando l'Italia ha una svolta per molti versi drammatica. Dopo il 1918 arriva quel 1922 della marcia su Roma di Mussolini, preannunciata dai toni violenti dei cortei studenteschi nella Bologna dell'aprile 1915.
2004. Il mercante dei destini comprati
[Fonte dell'articolo]
Ambientato nel primo Ottocento, il nuovo romanzo di Piero Meldini, "La falce dell'ultimo quarto" (Mondadori, 186 pp., 16 euro), racconta la storia di Bartolomeo Bartolini che "discendeva da svariate generazioni di commercianti di granaglie. Gli anni di abbondanza li avevano resi ricchi; quelli di carestia ne avevano raddoppiato il patrimonio: perché, piovesse o splendesse il sole, fossero i raccolti magri o abbondanti, erano sempre loro che fissavano i prezzi, loro che intascavano i guadagni". Sullo sfondo c'è una Rimini i cui abitanti hanno uno speciale genio per intrighi e pettegolezzi: litigiosi e "condiscendenti con se stessi ma inflessibili con gli altri", amano godere delle altrui sconfitte più che delle loro vittorie. Il risultato si vede: "Così la città deperiva a vista d'occhio, come un corpo i cui organi siano in guerra fra loro. E come un uomo malato, più peggiorava più si isolava dal mondo circostante". Lo speziale Gioseffo, protagonista secentesco de "L'avvocata delle vertigini" (opera seconda di Meldini, 1996) già aveva detto di Rimini: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Forte del suo denaro, Bartolomeo Bartolini progetta di condizionare il futuro della propria famiglia con la stessa sicurezza con cui opera negli affari. Vedovo e con un figlio che ha tutt'altri interessi, privilegia nel rapporto umano ed aziendale un nipote ex fratre che gli dà grandi soddisfazioni. L'occhio del commerciante di granaglie osserva i loro comportamenti, cerca di indirizzarne la vita secondo i propri piani. Usa come strumento le volontà testamentarie, che muta in continuazione adeguandole agli eventi sorprendenti o dolorosi e tragici che si susseguono nella sua famiglia. Quegli atti notarili che lui fa stendere con inutile preveggenza e consolatorie provvidenze, rappresentano ai suoi occhi la certezza che il destino dovrà avere il corso che lui immagina. Ma le singole esistenze del figlio e del nipote subiscono scarti dalla linea prefissata. Il libero arbitrio delle persone non si fa comperare dal mercante che detta i testamenti con la stessa arroganza con cui può dirigere le compre di grano o stabilirne il prezzo.
Bartolomeo Bartolini è un "uomo tolemaico", una di quelle persone cioè che si considerano al centro dell'universo, come era la terra nell'antico sistema soppiantato dall'eliocentrismo copernicano. E reputa che quanti gli gravitano attorno ricevano da lui luce e calore, ovvero la vita. Ma le pagine dell'esistenza quotidiana di ognuno si girano senza che il ricco mercante possa fermarle. Non gli resta che tentare di resistere al destino, alla Mietitrice che incombe nel dolore e nella malattia, con la speranza sempre più debole, che un filo, un filo soltanto di tutta la matassa esistenziale, gli conceda la possibilità di governare l'altrui destino, le sorti della ditta e della famiglia.
Ma anche quel filo si logora, probabilmente nella meccanica, continua ripetizione d'un fallimento dei suoi progetti. Il romanzo si chiude senza spiegare come e quando si spezzerà l'ultimo sogno. Il lettore può pensare che alla fine, nell'ultimo giorno, a Bartolomeo Bartolini resterà soltanto il ricordo di un'illusione, senza che niente di quanto lui avrebbe voluto e desiderato, possa avverarsi. Il destino degli altri non si compra con il denaro del testamento, non è una partita di granaglie, non è un contratto capestro, non è la forza corruttrice di un'elemosina elargita al clero per avere soddisfazione alle proprie pretese, non è il gioco mondano che permette, a lui ricco, di chiedere per i suoi due eredi la mano di ragazze aristocratiche d'una famiglia in rovina economica.
No, il destino individuale non è in vendita. E Bartolini se n'accorge ogni volta che costringe il notaio a modificare le proprie volontà: "predeterminava le esistenze dei suoi discendenti, e dei loro nati, poneva un'ipoteca sul più lontano futuro". Se n'accorge, ma non lo confessa. Va sempre avanti così, con quell'illusione che lo sorregge nella continua battaglia con la Mietitrice. Con cui dialoga anche nell'ultima pagina: "Aspetta. Che fretta hai?".
Meldini offre in questo quarto romanzo (a dieci anni dal debutto narrativo di successo con "L'avvocata delle vertigini"), un'altra prova di grande maturità artistica che s'esprime anzitutto nello stile con cui costruisce il racconto, poi nella stessa scansione degli eventi che procedono narrando la normalità di vite qualunque, nelle quali si condensano però le ferite simboliche, le angosce nascoste, le speranze tagliate di tutti.
L'abilità dello scrittore dissemina lungo il testo sapienti suggestioni che si offrono al lettore con la discrezione di appunti delicati, senza ostentazioni arroganti. Si veda la scena della nebbia, nella quale il mercante prova "una paura che affondava in ricordi antichi e che riaffiorava di tanto in tanto nei sogni. Era la paura di dissolversi; di disperdesi in una miriade di atomi disertori; di diventare polvere e fumo".
Quegli "atomi disertori" valgono da soli un'emozione che il lettore incassa sollecitando in se stesso un confronto con l'altra pagina in cui a Bartolini sembra di poter veramente raggiungere il suo scopo, combinando il matrimonio del nipote, in una splendida giornata di fine dicembre: "Il cielo era di un fulgido e immacolato color zaffiro, e il sole illuminava tutte le stanze sul davanti della casa, a cominciare dalla sala da pranzo. La luce dorata che entrava dalle finestre, alleata al tepore che spandeva il fuoco del camino annunciava la primavera". Ma quella luce e quel tepore sono un inganno, a conferma che le immagini che scorgiamo non rendono piena testimonianza della verità delle cose, come la figura del santo vescovo Gaudenzio che in piazza della Fontana, "dall'alto del piedistallo, lo guardava arcigno. Il braccio levato sopra la testa e le tre dita aperte non sembravano impartire una benedizione, ma lanciare una scomunica".
1999. Le "lune" dolorose di Meldini
[Fonte dell'articolo]
L'"avvocata delle vertigini" del primo romanzo (1994, Adelphi) non ha mai avuto il dono dell'essere nella carne e tra le cose del mondo, ma Meldini le plasma attorno una biografia che ne fa un personaggio vero, non improbabile e neppure assurdo. Anzi quasi esemplare. L'astuzia narrativa dell'autore introduce leggende che "accennavano, concordi, ad una giovinezza alquanto dissipata", a cui tenne dietro la conversione, dopo un fatto straordinario che muta radicalmente la vita di questa giovane dal nome di Isabetta. Il fatto è un tentativo di suicidio dall'alto di un campanile: ma a salvarla intervengono provvidenzialmente quelle vertigini di cui parla il titolo, e per le quali diventa protettrice di quanti soffrono del male che le impedì il salto nel vuoto.
La storia letteraria dell'"avvocata delle vertigini", è soltanto lo spunto per proiettare il romanzo da questo medioevo (letto e rivissuto attraverso pagine biografiche o documenti), alla nostra realtà contemporanea che s'intravede come sfondo alle scene che inquietano la vita di personaggi dalle esistenze sino ad allora piatte, e turbate all'improvviso proprio dalla presenza di fantasmi di carta che ben presto però diventano minacciosi eventi reali.
Nel secondo romanzo "L'antidoto della malinconia" (1996, Adelphi, Premio Selezione Campiello), Meldini intreccia le parti del suo racconto (ambientato in un cupo scenario di fine Seicento), mescolandovi gli ingredienti più vari. Un amore negato dalla famiglia a Matilde, invaghitasi dell'"uomo sbagliato", per cui viene rinchiusa in monastero. La disperazione di Matilde (figlioccia dello speziale maestro Gioseffo, ed incline "ai pensieri malinconici"), finita pur essa nel suicidio. Il violento "uomo sbagliato" che torna riverito in società, nonostante la macchia di un delitto nato, "nelle fitte nebbie del vino", da una contesa inizialmente intessuta "per gioco". E sullo sfondo Rimini, contro la quale inveisce maestro Gioseffo: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Gioseffo lavorava ad un trattato, da cui Meldini riprende il titolo per il suo romanzo. Lo stratagemma dell'autore moderno di rifarsi all'autore antico, di scrivere un libro su di un libro che non esiste più perché distrutto alla fine dallo stesso Gioseffo ("...cominciò a strappare le pagine a una a una. Il fuoco, onnivoro, le divora con noncurante ingordigia"), permette di realizzare (ancora una volta, come nell'"Avvocata"), una trama leggibile su due piani: in superficie, c'è il racconto delle apparenze (la vita così come ci si mostra), mentre la sottile ma intensa filigrana fa intravedere la "substantia rerum", ed i segreti individuali che si scontrano con quelle stesse apparenze.
La terza prova di Piero Meldini ("Lune", Adelphi, 1999) naviga con grande perizia stilistica in un territorio misterioso ed enigmatico, per dimostrare montalianamente che il calcolo dei dadi mai non torna. E' un racconto fatto in prima persona, nell'angoscioso momento dell'attesa di un intervento chirurgico, con il drammatico rincorrersi di silenzi pungolanti alla meditazione, con l'immagine soave e terribile di un giovane morente, con le infermiere che recano tisane, prelevano sangue. Tutto ha il colore di una paura che spinge il protagonista a spiegarsi in un "grosso quaderno con la copertina nera e i tagli rossi che ricorda un messale".
Sale quasi dall'inconscio l'immagine purificatoria del messale, dove saranno però contenute anche notizie di un carattere tutto sfrenatamente istintivo, che Meldini presenta senza alcun compiacimento, per testimoniare che Andrea Severi, il suo protagonista, vuole stendere un freddo (tuttavia compromettente) verbale a futura memoria, per chiarire a se stesso la serie degli eventi accaduti durante un viaggio in Grecia.
Il libro non si può raccontare, non solo perché la sua conclusione va compresa soltanto dopo averlo letto tutto e non anticipata per gusto di pura cronaca; ma anche perché una volta giunti a quella conclusione, si deve ripassare mentalmente tutta l'opera, cercare di coglierne la struttura ed il valore simbolico dell'indecifrabilità del mondo in cui viviamo, testardamente convinti di essere, tutti noi, registi astuti nell'ideare e costruire ogni passo, ogni momento e situazione.
L'abilità dell'autore sta nel presentarci questa storia complessa con la massima semplicità possibile, con quella 'leggerezza' che può nascere soltanto da un perfetto controllo tecnico e formale della materia. Senza di essa, il racconto avrebbe avuto il carattere non dello straordinario, ma dell'ovvio e del quotidiano; e non avrebbe reso il senso della ricerca del filo per dipanare la matassa delle incongruenze, delle contraddizioni e delle incomprensioni che ci accompagnano.
C'è una frase in cui Meldini riassume il senso del 'castello' entro cui agiscono i suoi personaggi: "Quando, nella rassicurante casualità dei fatti, ci sembra di cogliere una traccia di maligna ostinazione, invochiamo il destino. Qualche volta succede anche a me di pensare che una volontà misteriosa governi gli eventi [...]".
Verso la fine del suo 'verbale', ad Andrea Severi sembra che le parole scritte su quel quaderno si scompongano e ricompongano "per cancellare questa storia". Ma la vita non si cancella. Aspetta di essere raccontata. Sempre.
1996. La malinconia, "epidemia del secolo"
[Fonte dell'articolo]
A due anni dal fortunato esordio con "L'avvocata delle vertigini", Piero Meldini torna in libreria e conferma la sua qualità di felice, originale narratore. Il nuovo libro "L'antidoto della malinconia" (Adelphi, lire 22.000), prosegue il discorso tematico avviato con l'opera prima, di cui ha la stessa natura di racconto filosofico. Rispetto ad essa, presenta però una visione più amara e tragica della realtà umana. Se Isabetta veniva salvata provvidenzialmente dal suicidio, il protagonista di questo secondo romanzo (lo speziale maestro Gioseffo), non ha nessuno che lo trattenga dal mettere in atto il suo disperato progetto.
Nella conclusione della vicenda di maestro Gioseffo, il lettore avverte con commozione la discesa della parabola esistenziale di un personaggio che attraversa le varie scene (della vita e del libro), con una lucida e sofferta meditazione la quale sottolinea, momento dopo momento, ansie, contraddizioni, persecuzioni quotidiane.
Ancora una volta, Meldini intreccia le parti del suo racconto (ambientato in un cupo scenario di fine Seicento), mescolandovi gli ingredienti più vari. Un amore negato dalla famiglia a Matilde, invaghitasi dell'"uomo sbagliato", per cui viene rinchiusa in monastero. La disperazione di Matilde (figlioccia dello speziale, ed incline "ai pensieri malinconici"), finita pur essa nel suicidio. Il violento "uomo sbagliato" che torna riverito in società, nonostante la macchia di un delitto nato, "nelle fitte nebbie del vino", da una contesa inizialmente intessuta "per gioco". E sullo sfondo Rimini, contro la quale inveisce maestro Gioseffo: "Città ingrata, più contenta delle altrui disgrazie che delle proprie fortune, cieca ai meriti, insensibile all'ingegno. Patria disgraziata!".
Gioseffo lavorava ad un trattato, da cui Meldini riprende il titolo per il suo romanzo. Lo stratagemma dell'autore moderno di rifarsi all'autore antico, di scrivere un libro su di un libro che non esiste più perché distrutto alla fine dallo stesso Gioseffo ("...cominciò a strappare le pagine a una a una. Il fuoco, onnivoro, le divora con noncurante ingordigia"), permette di realizzare (ancora una volta, come nell'Avvocata), una trama leggibile su due piani: in superficie, c'è il racconto delle apparenze (la vita così come ci si mostra), mentre la sottile ma intensa filigrana fa intravedere la substantia rerum, ed i segreti individuali che si scontrano con quelle stesse apparenze.
La dimostrazione di questo procedere (ambiguo non in sé, ma tale soltanto perché rispecchia e riproduce la duplicità dell'esistenza), è proprio nella pagina conclusiva del romanzo di Meldini. Il notaio Bentivegni, cronista della città e fonte preziosa per i futuri "avveduti" lettori, annota "addì 7 novembre 1690" la notizia del ritrovamento del corpo di maestro Gioseffo, e riferisce sul libro da cui egli attendeva la fama: "Il manoscritto non è stato trovato. C'è chi dice che maestro Gioseffo l'abbia distrutto in un moto d'ira. Chi mormora che gli sia stato rubato. I più maligni insinuano che non sia mai esistito se non nella sua immaginazione, fervida quanto alterata. Costoro sostengono che le pagine del libro che lo speziale porse al suo augusto protettore, in accademia, fossero tutte bianche".
Le ultime righe della citazione riferiscono l'avvenimento in cui culmina la vicenda personale di Gioseffo. Accortosi che l'"augusto protettore" (un gelido cardinal Legato), non aveva letto neppur una delle numerose lettere che gli aveva scritto con sofferta elaborazione, Gioseffo gli si ribella proprio nel momento che doveva esser per lui di maggior gloria, sotto gli occhi di tutta la ridicola "accademia dei Pennuti". All'"augusto protettore", egli non porge l'omaggio del libro, ma pronuncia parole che suonano estranee e stonate, in quell'ambiente, come risultava a lui stesso la sua voce: ""Tiranni come la sorte," mormorò "e altrettanto ciechi, i Grandi concedono i loro favori, o li negano, come detta loro il capriccio. [...] Fieri del loro potere, abbagliati dalla loro bellezza, appagati dalla loro perfezione, i Grandi" disse "non vedono e non sentono. [...] Ma che preghiamo o imprechiamo," gemette "che sussurriamo o gridiamo, la nostra è la voce di poveri uomini. Di poveri uomini inascoltati."".
Messo a tacere, tra i rumori di protesta dell'aula, lo speziale fece ritorno a casa, per scrivere l'ultimo capitolo della sua vita, consistente nel cancellare col fuoco il libro in cui aveva cercato di distillare sapientemente l'antidoto alla malinconia, "veleno dei letterati" ed "epidemia del secolo". Dalla fine di quel libro -di Gioseffo-, comincia questo -di Meldini-, cioè inizia il gioco letterario che l'autore moderno argutamente conduce, rendendosi complice ed antagonista al tempo stesso, dello scrittore antico. Dalle ceneri delle pagine di Gioseffo, prendono forma le pagine di questo 'malinconico' romanzo riminese.
1994. "L'avvocata delle vertigini"
[Fonte dell'articolo]
Il romanzo di Piero Meldini ha una struttura composita: si presenta sin dall'inizio come un racconto fitto di misteri, e finisce per essere in sostanza il resoconto probabile dell'unico mistero che attanaglia l'uomo, quello della sua stessa esistenza.
Per rendere questa struttura, l'autore fa ricorso ad una serie di artifizi narrativi, con abbondanza di provocazioni letterarie che attirano il lettore all'interno di una specie di labirinto, ove si mescolano suggestioni eleganti e disperati resoconti di cronaca nera: è una specie di grande gioco delle ombre cinesi, o se si vuole una specie di riproposta del mito platonico della caverna. Le cose che ci stanno di fronte, che cosa rappresentano? Gli accadimenti, anche i più tragici, a che servono, da chi sono voluti? Il fattaccio di sangue, le tracce che spaventano i frettolosi passanti di una città qualsiasi (ma sappiamo, è la nostra città), hanno una loro logica, o sono uno scherzo del destino? O piuttosto non qualcos'altro ancora, che non sveliamo per non togliere al lettore il gusto di scoprire da solo significati, meriti e sostanza di questo romanzo.
La storia parte dal personaggio a cui va l'onore del titolo del libro, quell'"avvocata delle vertigini" che non è mai esistita storicamente. Quando Alberto Cousté ha presentato tempo fa, alla Sala degli Archi, il suo "Sigismondo" edito da Longanesi, un romanzo storico che non teme l'invenzione, ha dovuto rispondere all'osservazione di chi gli faceva notare che a Pesaro non si trova una certa porta di cui parla nel libro. La sua risposta è stata: "Non c'è, ma io l'ho vista".
Anche la nostra "avvocata delle vertigini" non ha mai avuto il dono dell'essere nella carne e tra le cose del mondo, ma Meldini le plasma attorno una biografia che ne fa un personaggio vero, non improbabile e neppure assurdo. Anzi quasi esemplare. L'astuzia narrativa dell'autore introduce leggende che "accennavano, concordi, ad una giovinezza alquanto dissipata", a cui tenne dietro la conversione, dopo un fatto straordinario che muta radicalmente la vita di questa giovane dal nome di Isabetta. Il fatto è un tentativo di suicidio dall'alto di un campanile: ma a salvarla intervengono provvidenzialmente quelle vertigini di cui parla il titolo, e per le quali diventa protettrice di quanti soffrono del male che le impedì il salto nel vuoto.
La storia letteraria dell'"avvocata delle vertigini", è soltanto lo spunto per proiettare il romanzo da questo medioevo (letto e rivissuto attraverso pagine biografiche o documenti), alla nostra realtà contemporanea che s'intravede come sfondo alle scene che inquietano la vita di personaggi dalle esistenze sino ad allora piatte, e turbate all'improvviso proprio dalla presenza di fantasmi di carta che ben presto però diventano minacciosi eventi reali.
Piero Meldini è scrittore e saggista da una vita e lavora come direttore della Biblioteca Civica Gambalunghiana di Rimini. E al centro del romanzo troviamo proprio un bibliotecario, il cui cognome (Manara) riecheggia il nome di quel Manara (Valgimigli) che fu anch'egli bibliotecario ed illustre studioso. Con il personaggio Manara, Meldini all'inizio si è divertito: lo ritrae come colui che spopola la biblioteca Giacomo Antonio Passeri che finisce per non avere più lettori, per poter "trasmettere lo scibile, intonso, a improbabili posteri".
Nell'evolversi del racconto, il paradosso e l'invenzione cedono il passo ad una sofferta riflessione sulla realtà ultima della vita: "Oggi mi sono chiesto, non rida, se Dio esiste [...] E come sarà di là [...]. Perché ogni Sua manifestazione è una minaccia?". E poi ancora: "Affacciato alla finestra, il vescovo riascoltava, tremante, le parole di Agostino: "Cercavo da dove viene il male, e lo cercavo male, e non scorgevo il male della mia ricerca"".
L'impianto e lo svolgimento di quest'opera ne fanno un racconto filosofico: il lettore viene condotto a riflettere su pagine che Meldini ha composto con attenzione e passione. C'è in esse una grande sapienza narrativa che si esprime sia nella costruzione stilistica sia in quella della trama, ove il vivere attuale trova posto come qualcosa di impensabile o strano: il clima del racconto sembra infatti proiettare la vicenda in una situazione antica, invece tutto si svolge ai nostri giorni, a cui sono collegati i tempi fuggiti dell'"avvocata delle vertigini".
Vertigini che ritornano simbolicamente a chiudere le pagine in cui "una furtiva invocazione" ad Isabetta si accompagna al "grido muto al Dio appeso in cucina dell'infanzia fiduciosa, roseo e benedicente". È qui che il vescovo riascolta Agostino, e "a sua immagine e somiglianza, sentì, il Signore Dio suo era infelice".
Archivio Scrittori riminesiAntonio Montanari Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Storie e storia di Rimini